Oltre il conflitto delle Facoltà: dove sta la morale?
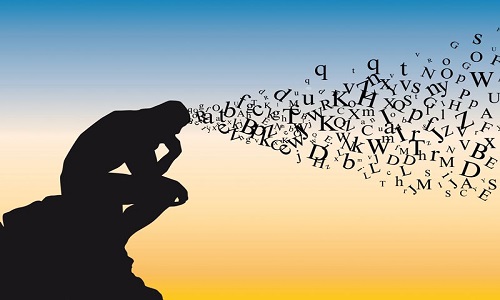
Dati di fatto
È inutile nascondersi dietro un dito. Ai nostri giorni un filosofo morale, in Italia e fuori d’Italia, può formarsi intellettualmente e passare la propria intera vita professionale senza porsi il problema del confronto con un punto di vista teologico sulla propria disciplina, in casi estremi senza nemmeno essere consapevole della sua esistenza.
Per evitare di fare la figura del saputello, premetto che io sarei potuto essere la prova vivente di questo enunciato perché, se la sorte con i suoi strani giri non mi avesse portato a lavorare in un Centro per le scienze religiose, è probabile che pure io balbetterei di fronte alla richiesta di nominare anche solo un teologo morale italiano di valore. Al contrario, oggi posso annoverare due teologi, uno morale, Antonio Autiero, e uno sistematico, Davide Zordan, nel mio personale pantheon degli studiosi da cui ho imparato di più nella vita.
La spiegazione di questo blind spot è sia sociologica che (meta)filosofica. Quando parliamo di secolarizzazione abbiamo spesso in mente idee sbagliate, ma non andiamo troppo lontano dal vero se ce la figuriamo anzitutto come lo scorporamento e il successivo trasferimento di funzioni tradizionalmente attribuite a una istituzione religiosa (nel caso europeo, le chiese nazionali) a ordinamenti secolari. Il governo delle coscienze è una di queste. E se per età secolare, seguendo l’insegnamento di Charles Taylor, intendiamo un’epoca in cui si è affermata a livello di massa l’opzione dell’umanesimo esclusivo, non stupisce che in una società secolarizzata possa esistere un numero consistente di persone che considera la morale un ambito dell’esistenza del tutto indipendente dalle credenze religiose, soprattutto nella fascia più scolarizzata della popolazione.
Questo è il sommovimento geologico che ha cambiato radicalmente il panorama dello studio sistematico delle condizioni di una vita moralmente degna, facendoci transitare da una situazione in cui l’autarchia della giustificazione filosofica in ambito etico era semplicemente una delle opzioni in campo, a una in cui essa è vissuta dalla maggioranza degli esperti del settore come un requisito epistemologico basilare.
Ai nostri giorni questo modo di incorniciare tacitamente il fenomeno morale è rafforzato dalla tendenza ormai sistemica a irrigidire i confini tra le discipline. Così, in un ambiente sempre più dominato dallo stile di pensiero «purista» della filosofia analitica, la convinzione che il ragionamento morale tematizzi pretese di validità diverse da quelle oggetto del discorso scientifico o estetico – esistenziale – espressivo può facilmente trasformarsi in una difesa compulsiva dei confini disciplinari dall’intrusione di voci che fanno appello a ragioni a cui non viene riconosciuto diritto di parola a monte, e non a valle, della discussione.
In questo orizzonte, per esempio, è quasi inevitabile che gli sforzi di ricontestualizzazione del fenomeno morale vengano di norma stigmatizzati come modalità di ragionamento allusivo e non rigoroso essendo percepiti come tentativi di differire all’infinito l’unico compito intellettuale legittimo: quello della giustificazione di un enunciato (o una catena di enunciati) perfettamente disambiguati, privi di sfondo.
È chiaro che quando prevale questo punto di vista, qualsiasi appello a un modello di ragionamento non geometrico o che lasci uno spazio epistemico significativo a una relazione non neutrale o impegnata con il proprio oggetto di studio è destinato a rimanere inascoltato, se non addirittura serenamente ignorato, non essendo registrabile dai sensori attivi nel campo di indagine della filosofia morale «secolare», per la quale cose come la fede, la rivelazione o il dogma sono fenomeni talmente stravaganti da poter passare inosservati (a patto che non pretendano di interferire nelle pratiche inferenziali). È questo quello che ha in mente Habermas, quando con un vezzo tipico dell’intellettuale post–secolare, ama descriversi come «privo di orecchio religioso» (religiös unmusikalisch).
Perché non dovrebbe essere così?
Per chi interpreta la vicenda che ho condensato in una vignetta come la dilapidazione di un patrimonio intellettuale prezioso, la situazione appare, dunque, tutto fuorché rosea. Ma esiste un’alternativa realistica a questo stato di cose?
Se si esamina lo scenario appena descritto tenendo sullo sfondo il testo probabilmente più emblematico della politica culturale post-illuministica, ossia Il conflitto delle Facoltà di Kant,[1] è difficile scacciare l’impressione che tanto il sogno autarchico della filosofia contemporanea quanto la lotta della teologia per uscire da una condizione imposta di invisibilità siano indici di senilità: i sintomi più evidenti, cioè, di un avanzato processo di sclerotizzazione.
Da un lato, infatti, i tentativi dei filosofi contemporanei di guadagnarsi una patente di immacolata rispettabilità scientifica sembrano avviati a un naufragio quasi certo, costretti come sono a destreggiarsi tra la Scilla dell’impulso alla specializzazione e la Cariddi della pressione crescente a legittimare i risultati della propria ricerca sulla base della sua redditività. Dall’altro lato, la pretesa della teologia di non essere ridotta alla mera convalida (per quanto ingegnosa) di un determinato impianto dottrinale o di una certa «regola» di vita deve fare i conti con la difficoltà a trovare interlocutori genuinamente interessati ai risultati di un’investigazione guidata da un ideale gnoseologico comunque ibrido, se misurato secondo gli standard della epistemologia moderna.
Sono davvero lontanissimi i tempi in cui Kant poteva impegnarsi a difendere il diritto inviolabile di critica presentandolo come una risorsa indispensabile anche per discipline allora di fatto socialmente più rispettabili come la teologia, la giurisprudenza o la medicina. Negli ultimi due secoli il mondo è cambiato così profondamente che non si capisce mediante quali ragionamenti rigorosi o slanci della volontà potrebbe essere scongiurata una debilitante, ma liberatoria resa al fatalismo. Nell’epoca in cui ci è toccato in sorte di vivere è davvero difficile immaginarsi un ruolo non da comprimari per figure nobili ma ormai decadute come quella del/la filosofo/a e del/la teologo/a.
A giudicare dalla non ricchissima letteratura in materia, attualmente chi proprio non vuole arrendersi alla forza del destino e insiste nel difendere l’utilità di una collaborazione tra indagine teologica e investigazione filosofica ha a disposizione, mi pare, due diversi tipi di argomentazione.[2]
La prima è di stampo contestuale (o esternalista) e fa essenzialmente leva su un fatto noto: la crisi apparentemente strutturale delle diagnosi, un tempo molto popolari, dell’inevitabile declino della religione nella modernità. La maggioranza degli studiosi oggi, infatti, concorda che se, come tutto fa supporre, le religioni sopravvivranno all’onda d’urto del disincanto moderno, è auspicabile che esse mantengano un livello alto di articolazione interna dei contenuti delle loro credenze. In questo modo, però, si riesce al massimo a rendere meno plausibile l’estinzione spontanea del sapere teologico e più problematica la pretesa di autosufficienza delle filosofie morali autarchiche.
Il secondo argomento è più tematico, ma si fonda anch’esso su un dato di fatto, sebbene più contestabile del primo. Mi riferisco alla presa d’atto della complessità, solo parzialmente riducibile, dell’esperienza morale umana. Qui torna in primo piano il tema attorno a cui è stato costruito questo forum virtuale ed è su una nota, se non più ottimistica, quantomeno meno rinunciataria, che vorrei concludere il mio breve intervento.
Per anticipare in forma condensata l’esito del mio ragionamento, direi che qualsiasi pretesa di autosufficienza in ambito etico è destinata a naufragare di fronte al riconoscimento della compresenza di livelli diversi, e nondimeno essenziali, dell’esperienza morale, uno dei quali – quello che lega i valori al senso della sacralità – è interpretabile come un ponte naturale tra la riflessione teologica e quella filosofica in ambito etico.
Configurazione dell'esperienza morale
Per spiegarmi meglio, mi azzardo a offrire un’interpretazione ultraschematica della struttura dell’esperienza morale. Per cominciare, mi limito a ricordare che l’etica ruota attorno a una domanda che riguarda tutti, nessuno escluso: «Come dobbiamo vivere?» E la risposta a questa domanda, che si ripropone puntualmente nelle varie fasi di vita delle persone, prende forma in un campo che, a prima vista, sembra organizzarsi attorno a due poli opposti.
Da un lato, c’è il modo in cui siamo fatti: i desideri e i bisogni che semplicemente abbiamo. In proposito è sufficiente pensare a un elemento imprescindibile della vita quotidiana: il cibo. Noi veniamo al mondo con un impulso primario a nutrirci e con delle preferenze personali rispetto ad alcuni cibi che ci piacciono particolarmente. Sul fronte opposto, a questi desideri di primo grado si contrappongono dei precetti o degli obblighi a cui siamo soggetti per il semplice fatto di essere socializzati in una particolare comunità umana: «il cibo non si spreca» o «bisogna digiunare un giorno alla settimana» o «non si mangia la carne degli animali domestici», ecc.
In questo iato tra fatti e norma prende notoriamente forma il fenomeno morale. L’esistenza di questo gap non lascia tuttavia i nostri desideri inalterati. Una componente importante della domanda circa il modo in cui dobbiamo vivere è la curiosità che più o meno tutti hanno per ciò che veramente merita di essere desiderato, ciò che ha davvero valore, ciò che è bene per noi. Più che essere binaria, l’esperienza morale ha in effetti una configurazione triangolare. Da un lato, c’è il modo in cui siamo fatti (1); poi ci sono le norme che ci dicono quello che dobbiamo o non dobbiamo fare (2), e infine ci sono i valori «forti» verso cui orientiamo le nostre vite: il nostro senso del bene, del bello, di ciò che è veramente importante, persino sacro (3).
La mia impressione, che in questa sede per ovvi motivi posso soltanto enunciare, è che sia proprio qui, nella sfera dei beni e dei valori, che accadono le cose più sorprendenti, creative e arcane della condizione, sempre in bilico tra realtà e finzione, degli agenti e dei pazienti morali. E ho usato il verbo «accadere» non a caso, perché questo dinamismo è l’aspetto allo stesso tempo più interessante e più opaco della vita morale delle persone.
Siccome considero i teologi in genere, e i teologi morali in particolare, come grandi esperti dell’intricato rapporto tra la natura, la libertà e la regola, quando indosso il mio abito liso di filosofo morale, continuo ancora oggi ad aspettarmi da loro un contributo significativo nello sforzo comune, e tutt’altro che concluso, di gettare un po’ di luce sull’enigma probabilmente insolubile della relazione tra moralità e vita.
[1] Cf. I. KANT, Il conflitto delle facoltà, a cura di D. Venturelli, Morcelliana, Brescia 1994.
[2] Ho discusso le prospettive contemporanee di una collaborazione sistematica tra teologi e filosofi nello studio del fenomeno religioso in un libro scritto a quattro mani con Davide Zordan, In una stanza buia. Filosofia e teologia in dialogo, FBK Press, Trento 2014.
