Parole delle religioni
L’Innominato
Nell’epoca di papa Francesco
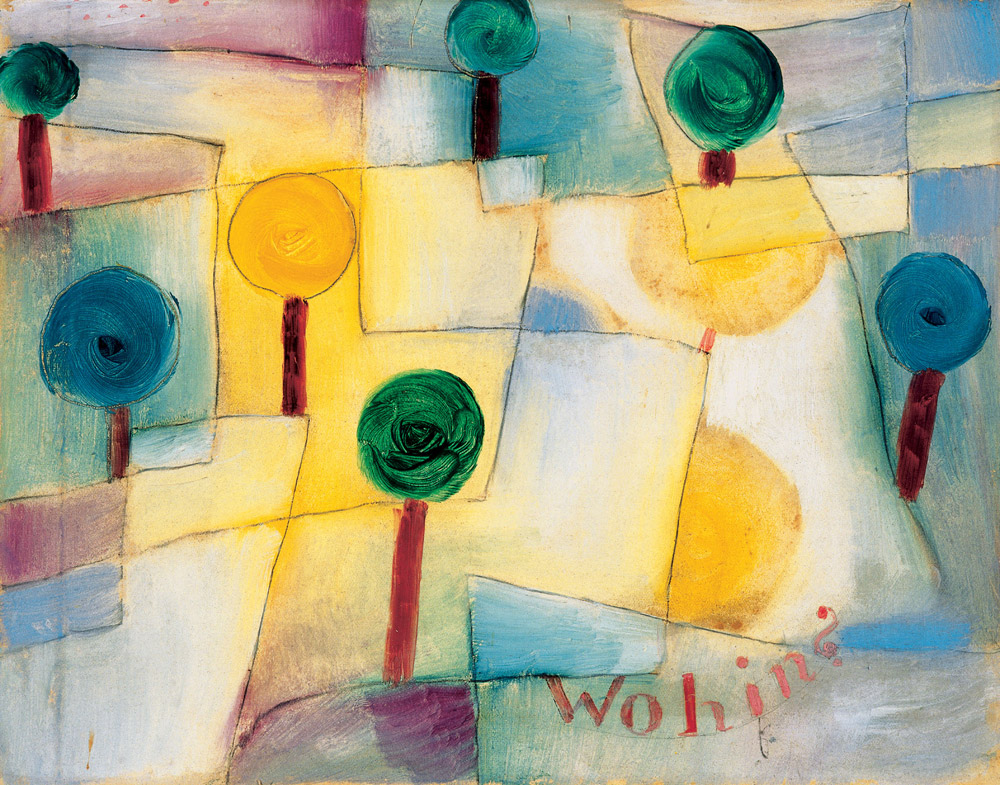
Leggere la vicenda manzoniana dell’Innominato all’epoca di papa Francesco produce risonanze particolari. Si è condotti quasi inevitabilmente a riflettere sulle dinamiche proprie della misericordia, parola chiave che anima i capitoli dedicati alla conversione del celebre personaggio dei Promessi sposi.
Oltre la comunità
Perdona e ama il prossimo tuo

Alla luce del Vangelo, la comunione è una realtà ancor più alta della comunità. O meglio ancora, la comunione è la comunità in cui è scomparso ogni contrasto.
Il sale della terra
E la beatitudine dei miti

La simbologia legata al sale è molteplice, infatti questa sostanza è dotata di vari usi. Limitiamoci al fatto che il sale insaporisce i cibi. Dà gusto agli altri, mentre, se assunto in modo diretto, è pessimo al palato. La lampada è accesa non già per essere vista ma per far vedere; se si guarda direttamente la fonte luminosa, lo sguardo rimane abbagliato per eccesso di vigore. Analogamente il sale dà sapore, mentre in se stesso è immangiabile. Esso svolge una funzione positiva solo nella misura in cui si disperde: per il sale donare sapore agli alimenti comporta la perdita della propria identità.
La fede e il timore
E il Dio incommensurabile

I tempi del vivere
Aforismi

Un detto di Buddha afferma che la forza dei bimbi è il pianto; si può aggiungere che quella dei più piccoli tra i piccoli è il loro bisogno esigente e inerme. Quando si è adulti questa forza si tramuta in debolezza: il bisogno non cattura più, di per sé, la premura altrui.
Fuori dal tempio
Leggere il Libro, leggere i libri

Quando si è presi dal fascino della lettura, tra le pagine e il loro lettore si instaura un rapporto affettuoso e intimo. Leggere significa star soli con il proprio libro: gli occhi importano assai più della voce. L’espressione «i miei libri» riguarda la proprietà in larga misura solo nel caso del collezionista o del bibliofilo; per il lettore appassionato indica invece una collezione di esperienze, di ricordi e di immagini che poco hanno da spartire con il possesso materiale. Tutto ciò vale anche per la Bibbia? Questa prassi solitaria è applicabile pure al «Libro dei libri»? Per rispondere, iniziamo da una considerazione che suona, ma non è, un semplice gioco di parole: la Bibbia non è solo il «Libro dei libri», è anche un «Libro di libri (o di libretti)».
Nascita e conversione
L'ebraismo e i propri confini

Chi è un ebreo? Dall'antichità e fino a oggi, la distinzione tra appartenenza religiosa all'ebraismo e appartenenza etnica/nazionale al popolo ebraico ha avuto confini variabili e cangianti.
I monti di Abramo
Nell’ebraismo e nell’islam

La ricerca della pace
Il contributo dei quaccheri

Voli di rondini
Immigrazione e lingua poetica

