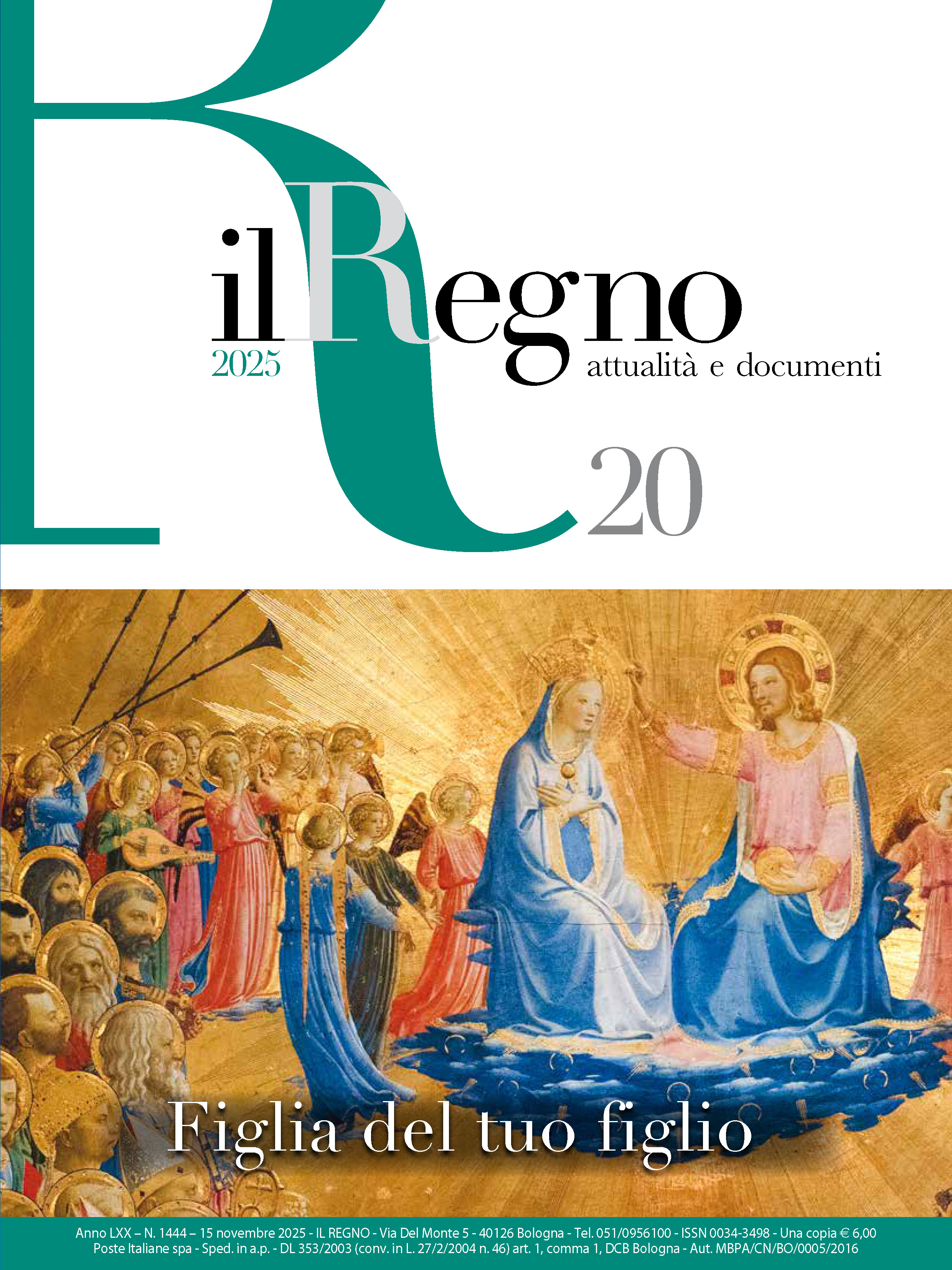A
Libri del mese
Libri del mese
Sempre più secolarizzata. Storia e attualità dell'informazione religiosa in Italia sui grandi media
Nelle nostre società secolarizzate, caratterizzate dalla dimensione pluralista, il sistema dei media è in posizione tale che, a parte nuclei sempre più ristretti di aderenti o adepti, è probabile che la maggior parte delle persone apprenda la maggior parte di quello che sa di una religione dai media; e che sulla base di queste informazioni così assunte elabori una propria visione di quella data religione e perfino un iniziale proposito di adesione, o all’opposto, una scelta di formale abbandono. Ciò significa che analizzare il modo della presenza delle religioni all’interno della comunicazione pubblica contribuisce a rispondere agli interrogativi su come si delinei la relazione tra la religione e le singole persone, nonché su quale sia il posto della religione in una società di questo tipo. Di qui deve discendere, per chi – non importa se credente o «diversamente credente», o indifferente o «in ricerca» – sia consapevole dell’importanza di tale relazione e di tale presenza, una duplice preoccupazione: da un lato analizzare i percorsi e i criteri attraverso i quali i grandi mezzi d’informazione «passano» la notizia religiosa e verificare se e come è possibile migliorarne la qualità; dall’altro promuovere, all’interno delle «associazioni religiose» (il discorso non vale solo per le Chiese), sia la capacità di comunicare se stesse in modo consapevole e fecondo, sia quella di educare a una fruizione critica dei media, a maggior ragione quando a qualunque titolo (informazione, fiction, pubblicità) si interfacciano con la religione.
Attualità, 14/2012, 15/07/2012, pag. 459
La regola è il discernimento. Il cuore del Vaticano II per chi non l'ha vissuto. Enchiridion del 50°
Cinquanta. Sono gli anni trascorsi dalla solenne celebrazione inaugurale del concilio Va ticano II l’11 ottobre 1962. Ma anche dalla nascita, su questa scia, delle Edizioni Dehoniane Bologna e dal fiorire della rivista Il Regno, che a partire da quegli anni divenne uno dei principali strumenti informativi sulle sessioni e sulla stesura dei documenti conciliari. Pertanto il volume che presentiamo tramite la postfazione del gesuita e teologo Christoph Theobald * non è un volume celebrativo tra i tanti. È parte integrante della nostra storia. E le sue parole, che prendono per mano la nuova generazione di lettori «che non ha né conosciuto né ha vissuto i primi tempi discretamente conflittuali della sua recezione», indicano in quell’avvenimento ecclesiale l’emergere di un metodo: quello della «pastoralità», che tiene insieme la tradizione e coloro che l’hanno trasmessa, la recezione e l’apprendimento. Ciò che il Vaticano II lascia in eredità è un modus operandi che afferma che il processo di trasmissione della fede non può che avvenire secondo un modo e in una struttura «relazionale». La speranza – dice Theobald – è di poter ritrovare nelle «Galilee» dell’oggi questa esperienza come una nuova grande grazia.
Attualità, 12/2012, 15/06/2012, pag. 385
Non solo per chi ha già la fede. Note sul progetto di pastorale giovanile dell'arcidiocesi di Milano
Un nuovo progetto organico e completo per la pastorale giovanile»: così il card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, presenta i tre volumi pubblicati dal Centro ambrosiano nella Lettera riportata nelle pagine iniziali. In effetti la lettura dei tre testi offre un panorama davvero ampio, articolato e completo per la formazione e la pastorale dei giovani. Sarà sufficiente offrire qualche assaggio, per apprezzare la ricchezza di questi testi. La maggiore attenzione qui riservata al primo volume, che è anche il più corposo, è dovuta all’ovvio carattere fondativo della cristologia rispetto sia all’ecclesiologia sia alla pastorale.
Attualità, 10/2012, 15/05/2012, pag. 315
I valori non consumati. La crisi economica ed educativa in Italia a partire da un'indagine europea
Il programma European values studies (EVS) è giunto alla quarta indagine, dopo quelle del 1981, del 1990 e del 1999. Ricercatori e studiosi di molti paesi hanno svolto un esame approfondito degli orientamenti di valore e dei convincimenti dei cittadini europei, quelli dei 27 paesi dell’Unione Europea (UE) e quelli di altri 21 paesi limitrofi, tra cui anche la Federazione russa e la Turchia. In attesa dei confronti transnazionali, i ricercatori italiani hanno pubblicato i dati relativi alla popolazione italiana, fornendo un quadro in ter pretativo generale e alcune ipotesi specifiche riguardanti i mutamenti culturali nei diversi ambiti di vita del nostro paese.1 Il risultato complessivo è un ampio affresco degli orientamenti di valore della popolazione italiana. Pur tenendo conto dei problemi insiti nelle indagini di questo tipo, i risultati che ci vengono offerti sono in grado di esprimere ciò che viene considerato meritevole di essere creduto, pensato e attuato da parte degli italiani. I valori tendono a diventare modelli di valutazione e predispongono all’azione, nel senso che la favoriscono e la motivano.
Attualità, 8/2012, 15/04/2012, pag. 243
No all'unisono, ma in armonia. Gesù nella letteratura contemporanea
When truly brothers, / men don’t sing in unison / but in harmony», «Se tra loro c’è vera fratellanza, / gli uomini non cantano all’unisono: / cantano in armonia». Degno, nella sua pregnanza semantica, di essere paragonato a un versetto di un libro sapienziale della Bibbia come il Qoèlet o il Siracide, ma anche alla folgorante luminosità di un pensiero di Blaise Pascal o di Simone Weil, questo aforisma in tre soli versi reca la firma del grande poeta e saggista britannico Wystan Hugh Auden. Appartiene infatti alla sua ultima silloge, Thank You, Fog (Grazie, nebbia), apparsa postuma nel 1974 e pubblicata in Italia nel 2011 da Adelphi, con la traduzione di Alessandro Gallenzi. Per chi ama ascoltare e magari anche praticare il canto corale, questa micropoesia senza titolo non può non evocare anzitutto, con l’impatto del suo significato letterale, il segreto dell’armonia che presiede all’arte eccelsa della polifonia sacra.
Attualità, 6/2012, 15/03/2012, pag. 171
Mille anni: Nel millenario di Camaldoli un volume fotografico ne celebra la ricerca spirituale
Come per altre «anime forti » del Medioevo, l’esperienza di Romualdo (952 – 1027 ca.) si connota anche per il fatto di volersi risolvere nel perimetro esistenziale e spirituale del suo tempo storico, di non proiettarsi intenzionalmente in un’istituzione alla quale affidare la custodia del carisma originario. Romualdo non è un fondatore di ordini religiosi, non lascia ai suoi discepoli alcuna regola e se esercita un ruolo di magister la sua eredità è di tipo eminentemente spirituale, si situa sotto l’egida della vigorosa e radicale testimonianza, di un mirabile esempio di vita raccolto da chi si è posto alla sua sequela.
Attualità, 4/2012, 15/02/2012, pag. 99
Tornare alla sorgente. La recezione del Vaticano II
Che possiamo attenderci oggi dal Vaticano II? Che cosa dobbiamo necessariamente attenderci da esso? E come interpretarlo? È con queste tre domande che abbiamo iniziato il nostro percorso sulla recezione del Vaticano II, ed è con esse che ora terminiamo la sua prima tappa. Invece di riconsiderarne gli elementi essenziali secondo l’ordine storico riflesso dalle cinque parti di questo volume, ne raccoglieremo i tre risultati principali, rispondendo alle domande in questione, sperando così di porre in risalto la logica interna dell’itinerario seguito.
Attualità, 2/2012, 15/01/2012, pag. 27
La Chiesa di sempre? I tradizionalisti alla conquista di Roma
L'ampio e documentatissimo libro di Giovanni Miccoli La Chiesa dell’anticoncilio si apre po nendosi, in sostanza, la stessa domanda avanzata da Benedetto XVI nella lettera da lui rivolta, nel 2009, ai vescovi, e dedicata a replicare alle molte perplessità nate dal precedente decreto della Congregazione dei vescovi con cui veniva revocata la scomunica latae sententiae comminata nel 1988 ai quattro vescovi illecitamente consacrati da mons. Lefebvre. Papa Ratzinger in quel testo si chiese se quel provvedimento «misericordioso» fosse davvero necessario e se costituisse una reale priorità. La risposta affermava che certamente vi erano cose più importanti, già chiaramente indicate fin dall’inizio del pontificato, la prima delle quali era di rendere presente Dio in questo mondo e di aprire agli uomini l’accesso al Dio che si rivelò al Sinai e, definitivamente, in Gesù Cristo morto e risorto. Tuttavia fa parte della missione della Chiesa attuare «anche le riconciliazioni piccole e medie». Inoltre «può lasciarci totalmente indifferenti una comunità nella quale si trovano 491 sacerdoti, 215 seminaristi, 6 seminari, 88 scuole, 2 istituti universitari, 117 frati, 164 suore e migliaia di fedeli? Dobbiamo davvero tranquillamente lasciarli andare alla deriva lontani della Chiesa? Penso ai 491 sacerdoti».
Attualità, 22/2011, 15/12/2011, pag. 747
San Tommaso l'innovatore. Cornelio Fabro nel centenario della nascita
Quello di Cornelio Fabro (Flumignano 1911 - Roma 1995) è un itinerario di ricerca ad mentem sancti Thomae: esso si articola come un «rinnovamento del tomismo », o meglio ancora come un ripensamento vigoroso dei presupposti speculativi che hanno mosso la ricerca filosofica dello stesso Aquinate. Tale rizionepensamento avviene in un fecondo confronto critico con la modernità filosofica: sia con la genesi dell’ateismo moderno sia con quegli autori come Kierkegaard che hanno dato solide basi per una rinnovata «filosofia della libertà».
Attualità, 20/2011, 15/11/2011, pag. 675
Simboli di una nazione. Il Risorgimento italiano e la Chiesa. Appunti su un tema storiografico
La celebrazione del 150° anniversario dell’unità italiana ha dato occasione negli scorsi mesi a numerose rivisitazioni di quello che è stato il processo di unificazione nazionale e a un rinnovato interesse della storiografia sull’argomento. Rivisitazioni tutt’altro che concordi, spesso anzi divergenti, che hanno anistoria mato dibattiti e discussioni intorno a un tema ancora capace di una forte presa sull’opinione pubblica. Si è trattato infatti di riandare a quel processo costitutivo dell’identità nazionale nel quale inevitabilmente si tendono a cercare, come in un imprinting genetico o piuttosto come in una colpa originale, i motivi di forza e di debolezza che il paese ha poi espresso nella sua anistoria successiva sino alle vicende di questi ultimi anni.
Attualità, 18/2011, 15/10/2011, pag. 603