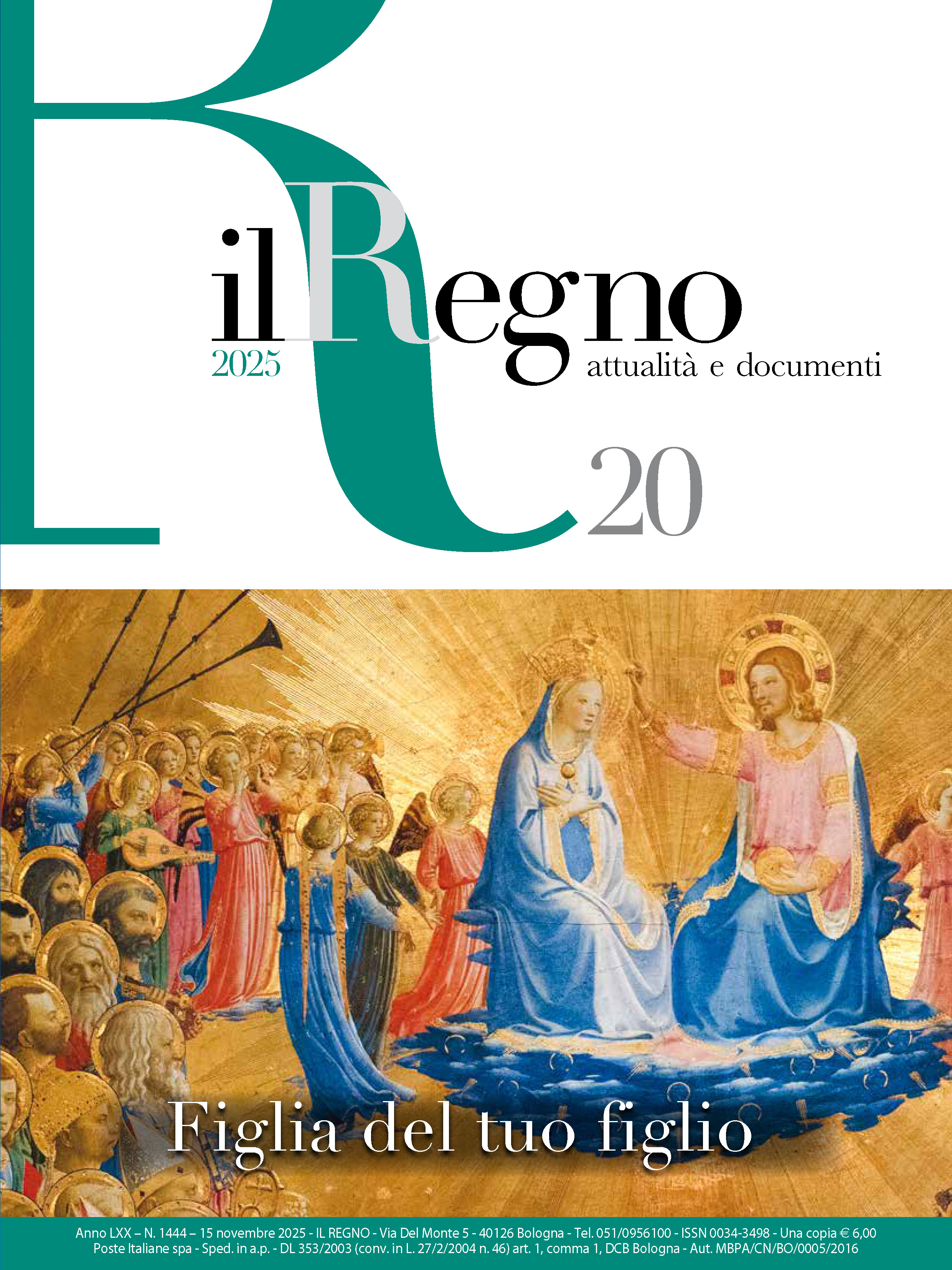A
Libri del mese
Libri del mese
Una cultura di carità. Quella Chiesa italiana che crebbe con mons. Nervo
Considero un privilegio poter illustrare la figura di mons. Nervo, che ho frequentato e con il quale ho collaborato per quasi l’intero arco della mia vita sacerdotale e che considero un grande dono del Signore alla Chiesa italiana e alla società nel suo insieme. D’altronde ritengo che Nervo
abbia influito nella comunità ecclesiale con la sua personale testimonianza, prima ancora che con le sue iniziative.
Attualità, 6/2014, 15/03/2014, pag. 171
Costantino: anniversario di un mito. L'Enciclopedia costantiniana e il punto storico-culturale
Preparato con largo anticipo da una serie tanto di celebrazioni culturali,
quali mostre e convegni in svariate città europee, quanto di pubblicazioni sia scientifiche sia di alta o meno alta divulgazione, il XVII centenario dell’editto di Milano ha certamente toccato il suo apice internazionale con un prodotto pensato, voluto e realizzato in Italia: Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano. 313-2013, opera definitoria e insieme
provocatoria già nel titolo, uscita appena qualche mese fa in tre grandi volumi per i tipi dell’Istituto della Enciclopedia italiana, noto al largo pubblico con il nome di Treccani.
Attualità, 4/2014, 15/02/2014, pag. 99
Lacrime sul cammino della Chiesa. Il Diario di Bartoletti e la nascita della CEI dopo il Vaticano II
Ho letto il Diario di Bartoletti (1916-1976) con l’emozione che provoca
il ritrovamento di un amico, grato ai curatori per aver fornito un testo utile
a conoscere un uomo al quale molto dobbiamo. Un vescovo nostro che con il suo «primato dell’evangelizzazione» possiamo collocare in una genealogia ideale del primato del Vangelo che ora Francesco predica con tanta energia.
Attualità, 2/2014, 15/01/2014, pag. 27
L'autenticità che affascina. Rileggendo il saggio di H. Arendt su Giovanni XXIII
Difficilmente un incontro potrebbe apparire più improbabile. Angelo Giuseppe Roncalli, come nota senza infingimenti la stessa Arendt, era tutto fuorché un intellettuale. Ma non furono di certo le sue idee originali ad attirare l’attenzione dell’autrice di Vita activa. A incuriosirla fu infatti soprattutto l’autenticità della religiosità di Giovanni XXIII e, ancor più, i suoi risvolti profondamente umani.
Attualità, 22/2013, 15/12/2013, pag. 709
L'irriducibile, semplice, coscienza. L'epistolario di Franz e Franziska Jägerstätter (1940-1943)
Jägerstätter, in contrasto con le tesi dominanti nel mondo cattolico, partiva da un'affermazione del primato della coscienza individuale del cristiano sull'obbedienza all'autorità ecclesiastica e politica in ordine alla partecipazione del fedele alla guerra.
Attualità, 20/2013, 15/11/2013, pag. 645
Profetessa nella storia. Il multiforme profilo d'Ildegarda di Bingen
La proclamazione d’Ildegarda di Bingen (1098-1179), monaca dell’ordine
benedettino, a dottore della Chiesa universale ha riacceso l’attenzione sulla figura poliedrica di un personaggio che, per l’originale amalgama di visionarietà e profezia, ricevette l’appellativo di «Sibilla del Reno».
Attualità, 18/2013, 15/10/2013, pag. 579
Riconciliare uomo e macchina. Ritratto di Adriano Olivetti (1901-1960) per mano di un amico
Siamo di fronte a una personalità forte e complessa, nella quale esperienza pratica e spirito innovatore, rigore scientifico ed esigenza estetica, genialità imprenditoriale e profondo e radicato senso di missione sociale convergevano, si fondevano, al di là di ogni apparente contraddizione, in un tutto unitario, diventando costume di vita.
Attualità, 16/2013, 15/09/2013, pag. 507
Il sapore del racconto. La narratologia biblica in Marguerat e Wénin
Assaporare un racconto «è un’esperienza antica quanto il mondo. Chi
non è stato conquistato, almeno una volta, da un narratore o da una narratrice di talento? Tutti, o quasi tutti, hanno gustato la magia di racconti, perché tutti, o quasi tutti, hanno avuto nella loro infanzia una
mamma, un papà, una nonna, un nonno che raccontava loro delle storie. In ogni epoca e sotto tutte le latitudini gli uomini si sono raccontati delle storie».
Attualità, 14/2013, 15/07/2013, pag. 435
Il cyborg. Corpo e corporeità nell'epoca del post-umano
Dalle paure più profonde nei confronti della tecnologia fino alla prospettiva etica di una governance efficace del progresso tecnologico: esplorando i modi in cui l’uomo fa uso della tecnologia, nonché i suoi più recenti sviluppi, si scopre che la tecnologia è inscindibile da chi siamo e da come pensiamo e che apre una serie urgente di quesiti etici che chiedono d’essere affrontati in maniera organica e condivisa. È questo
il percorso compiuto nel volume The cyborg di Paolo Benanti.
Attualità, 12/2013, 15/06/2013, pag. 363