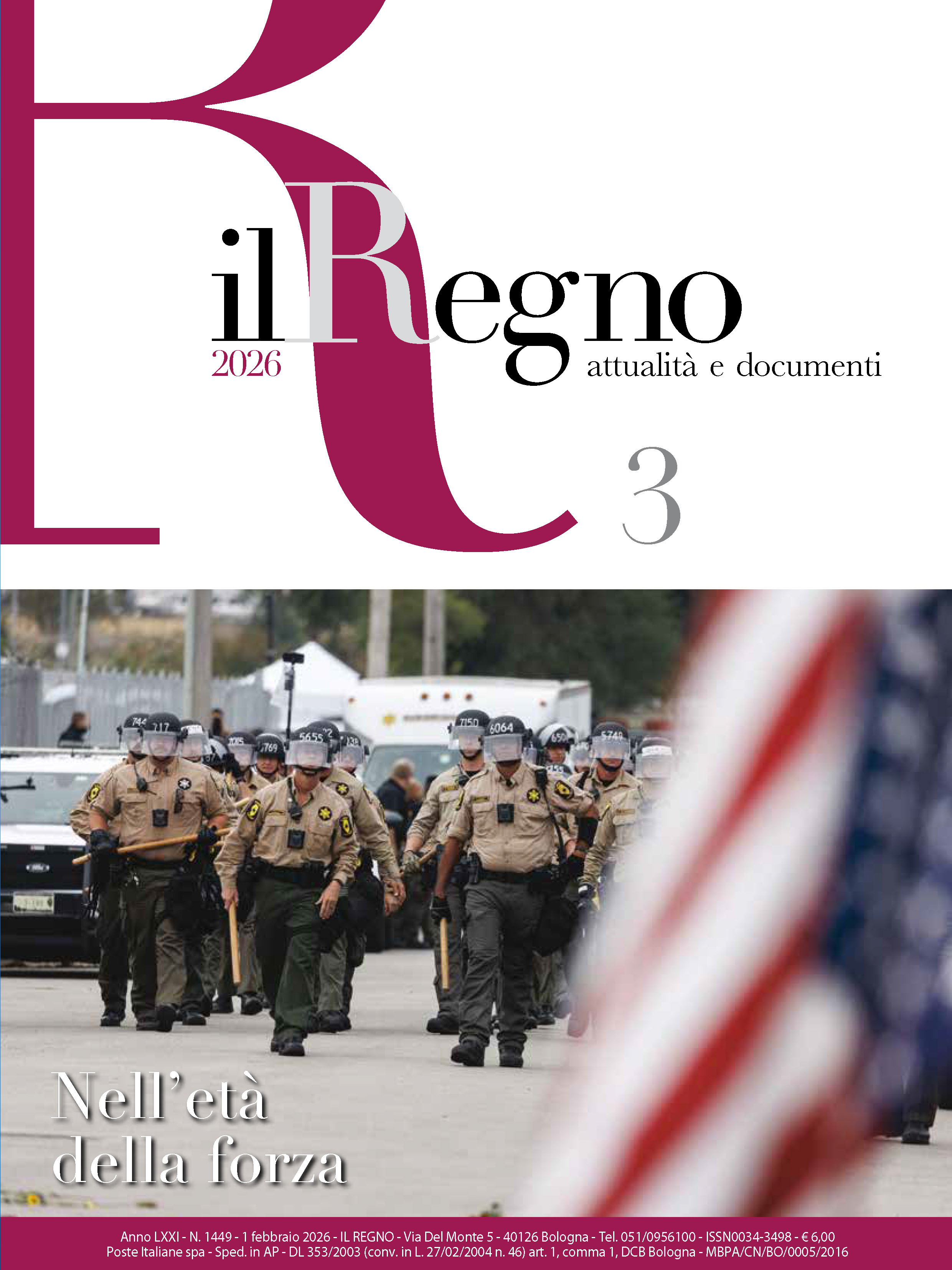Il Comitato nazionale di bioetica sul gene-editing; Chiese europee sul futuro dell’Europa; Rapporto annuale 2017 del Centro Astalli
AGENDA DOCUMENTI
23 febbraio 2017. Il Comitato nazionale di bioetica sul gene-editing. Nel contesto delle nuove tecniche dell’ingegneria genetica, in grado di modificare le sequenze del DNA degli organismi viventi con precisione, relativa facilità e costi contenuti, il Comitato nazionale di bioetica nel suo Parere del 23 febbraio 2017 analizza la tecnica CRISP-Cas9 (bioetica.governo.it). Il Comitato richiama la necessità di un ampio dialogo pubblico sul tema del gene-editing nei vari ambiti scientifici, etici, sociali, esprimendo una linea di prudenza rispetto a tecniche sperimentali che, allo stato attuale delle conoscenze, presentano forti margini d’incertezza, e sottolinea la necessità di trovare regole internazionalmente condivise per disciplinare la ricerca biomedica. È favorevole alla sperimentazione in vitro e animale, secondo le regole internazionali, per testare la sicurezza e l’efficacia delle tecnologie. Ritiene eticamente auspicabile un incremento della ricerca sulle cellule somatiche umane sia nell’ambito della ricerca in laboratorio sia nella ricerca clinica o in vivo. Ritiene non giustificabile la sperimentazione su gameti destinati al concepimento ed embrioni umani destinati all’impianto, concordando sull’opportunità della moratoria sulla ricerca clinica o ricerca in vivo finché non siano raggiunte le indispensabili condizioni di sicurezza ed efficacia della tecnica. Sulla sperimentazione del gene-editing in laboratorio sui gameti non destinati alla riproduzione e su embrioni in vitro non destinati all’impianto, invece, il Comitato si è diviso.
31 marzo 2017. Chiese europee sul futuro dell’Europa. Il card. Reinhard Marx, presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione Europea (COMECE, le Chiese cattoliche), e il rev. Christopher Hill, presidente della Conferenza delle Chiese europee (KEK, le Chiese protestanti e ortodosse), s’incontrano il 31 marzo per rafforzare l’impegno ecumenico nei confronti del progetto europeo, in tutti i nuovi modi che saranno necessari. Lo affermano in una Dichiarazione congiunta (www.comece.eu in inglese, tedesco e francese), nella quale vengono ricordate le iniziative dei due organismi su questo tema: il grande processo di consultazione avviato dalla KEK con la lettera aperta Quale futuro per l’Europa? (Regno-doc. 15,2016,505), e il Congresso che la COMECE e la Santa Sede terranno a Roma dal 27 al 29 ottobre sul tema «Ripensare l’Europa», un’opportunità di dialogo e riflessione congiunta tra vescovi, rappresentanti politici e altri soggetti ecclesiali insieme a papa Francesco, e un segno d’impegno della Chiesa cattolica a trovare nuovi modi di vivere insieme nel continente.
4 aprile 2017. Per il 50° della Populorum progressio. «Solo la strada dell’integrazione tra i popoli consente all’umanità un futuro di pace e di speranza», afferma papa Francesco il 4 aprile, ricevendo i partecipanti al convegno promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale il 3 e 4 aprile nel 50° anniversario della Populorum progressio. La riflessione si sofferma sul significato del verbo «integrare», indicato come «un orientamento fondamentale» anche per l’attività del dicastero promotore dell’iniziativa. Si tratta dunque «di integrare i diversi popoli della terra»; di «offrire modelli praticabili d’integrazione sociale»; di «integrare nello sviluppo tutti quegli elementi che lo rendono veramente tale», in modo che non solo «l’economia, la finanza, il lavoro» ma anche «la cultura, la vita familiare, la religione». Infine vanno riconosciute e garantite due ulteriori forme di integrazione: quella tra la dimensione individuale e la dimensione comunitaria, e quella tra corpo e anima.
11 aprile 2017. Rapporto annuale 2017 del Centro Astalli. L’11 aprile viene presentato il Rapporto annuale 2017 del Centro Astalli, sede italiana del Servizio dei gesuiti per i rifugiati (JRS), un’organizzazione cattolica internazionale, attiva in più di 40 nazioni, la cui missione è accompagnare, servire e difendere i diritti dei rifugiati e degli sfollati (centroastalli.it). Il Rapporto afferma che la chiusura, sia pur non totale, della rotta balcanica ha concentrato sulla rotta del Mediterraneo centrale la maggior parte degli arrivi via mare dei migranti forzati. Allo stesso tempo il ripristino dei controlli alle frontiere interne dell’Europa fa sì che la maggior parte dei migranti che arriva nel nostro continente resti in Italia. Nel corso del 2016 sono sbarcate in Italia 181.436 persone, di cui 25.772 minori non accompagnati. Le richieste di protezione internazionale presentate nel nostro paese nel corso dell’anno sono state 123.000. Ormai tutti i richiedenti asilo allo sbarco vengono distribuiti in tutte le regioni d’Italia, e il sistema di accoglienza nazionale ha registrato alla fine del 2016 un totale di presenze pari a 176.554 persone. La maggior parte di questi posti però continua a essere offerta da centri di accoglienza straordinaria (CAS), che non sempre prevedono lo stesso livello di servizi mirati all’integrazione e soprattutto non prevedono un coinvolgimento diretto dei comuni in cui si trovano. Il Centro Astalli, che gestisce sia centri di accoglienza straordinaria sia centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), auspica che la rete SPRAR diventi al più presto l’unico sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale, in modo che a tutti gli accolti possa essere garantito un supporto all’integrazione efficace e secondo standard uniformi.