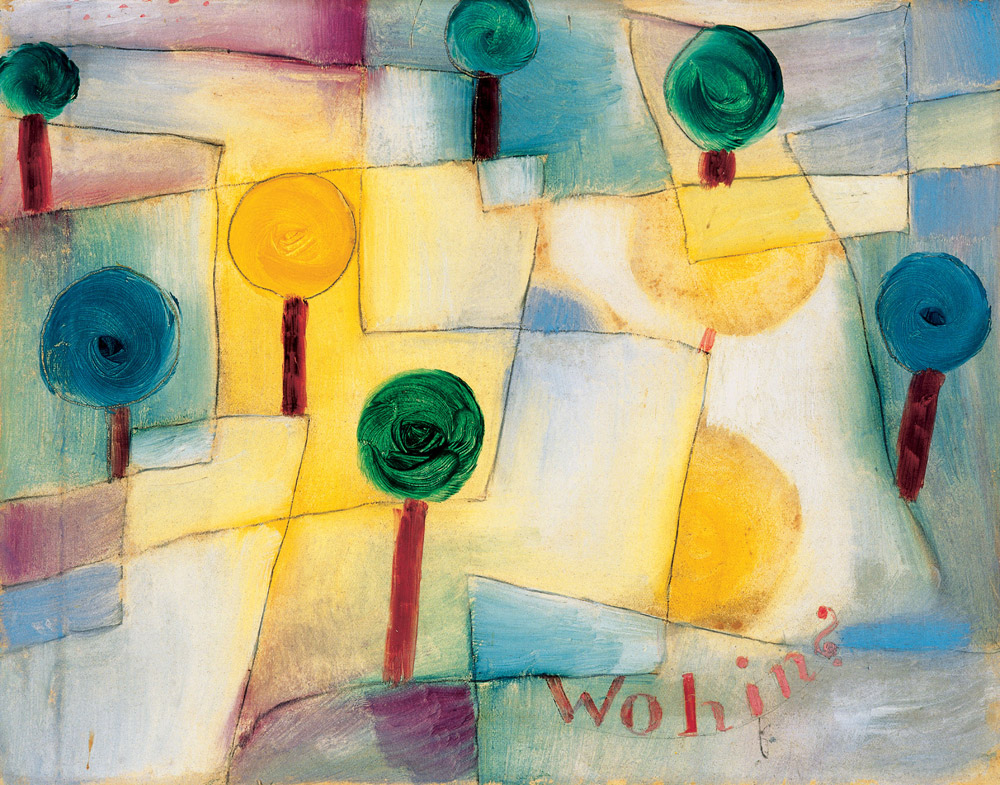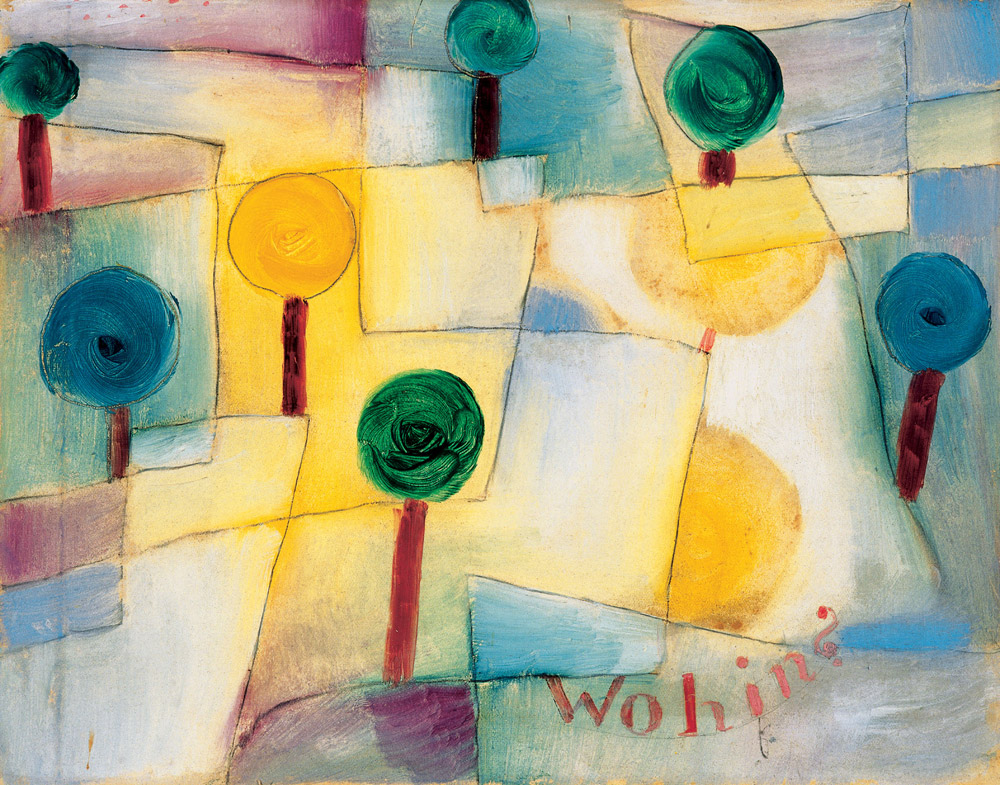I rapporti con l'ebraismo: un'amicizia tesa - Speciale Francesco

I rapporti di papa Francesco con il mondo ebraico sono schematizzabili lungo tre filoni principali: la prassi dialogica e le visioni teologiche che la innervano; le riflessioni sulla Shoah; i rapporti con lo Stato d’Israele, fattisi via via più complessi a seguito delle violente reazioni israeliane ai terribili fatti del 7 ottobre 2023.
Com’era nello stile di Bergoglio, i tre orizzonti sono collegabili alla presenza di alcuni rapporti personali. Nel primo caso si tratta soprattutto della fraterna relazione di lunga data con il rabbino argentino Abraham Skorka;1 nel secondo di quella con la scrittrice Edith Bruck, reduce dai Lager nazisti; nel terzo il pensiero va ai contatti molto frequenti con la parrocchia cattolica di Gaza.
Alle «relazioni con l’ebraismo» sono dedicati tre numeri (247-249) dell’Evangelii gaudium (2013), il documento programmatico del pontificato. Le affermazioni più qualificanti sono le seguenti: l’Alleanza tra Dio e il popolo ebraico non è stata revocata; la Chiesa «considera il popolo dell’Alleanza e la sua fede come radice sacra della propria identità cristiana»; «il dialogo e l’amicizia con i figli d’Israele sono parte della vita dei discepoli di Gesù»; occorre dispiacersi amaramente per «le terribili persecuzioni di cui furono e sono oggetto» gli ebrei, specie se coinvolgono cristiani; Dio «continua a operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina»; infine esiste una complementarietà che consente di leggere assieme la Bibbia ebraica.
Il punto fermo del Concilio
Papa Francesco in questi passi, come avrebbe esplicitato nel corso della sua visita al Tempio maggiore di Roma (17 gennaio 2016), riprende le linee della dichiarazione conciliare Nostra aetate, arricchite dall’asserzione, introdotta da Giovanni Paolo II nel 1980 e poi più volte ripresa,2 relativa all’Alleanza non revocata.
Rispetto alla recezione ebraica vi sono alcune difficoltà: il forte accento sulla sola Bibbia non corrisponde appieno allo spirito del giudaismo rabbinico; la visione ebraica prevalente non considera gli argomenti teologici oggetto di un dialogo da incentrarsi esclusivamente su valori condivisi; il riferimento allo Stato d’Israele non è mai trascurabile, in quanto parte integrante dell’identità ebraica complessiva.
La riflessione sulla Shoah, fatta più di eloquente silenzio che di parole, è legata soprattutto a due luoghi simbolo dello sterminio nazista: Auschwitz-Birkenau e lo Yad Vashem di Gerusalemme. Nel luglio del 2016 il papa volle interrompere il contesto festoso della Giornata mondiale della gioventù con una visita al più grande Lager nazista. In quell’occasione Francesco non pronunciò alcuna parola, il silenzio trovò un muto riscontro nelle due righe vergate sul libro degli ospiti «Señor ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad!». Il termine, così caro, di «popolo» in questo caso resta di interpretazione non univoca: era riferito solo al popolo ebraico o anche ad altri?
La domanda trova una parziale riposta nella visita privata fatta dal papa a Edith Bruck il 20 febbraio 2021, suscitata da un’intervista alla scrittrice apparsa su L’Osservatore romano: «Sono venuto qui da lei per ringraziarla della sua testimonianza e rendere omaggio al popolo martire della pazzia del populismo nazista, e con sincerità le ripeto le parole che ho pronunciato dal cuore allo Yad Vashem, e che ripeto davanti a ogni persona che come lei ha sofferto tanto a causa di questo: perdona Signore a nome dell’umanità».
Da quel giorno i due anziani si sono sentiti più volte al telefono, segno di una vicinanza parzialmente incrinatasi dopo il 7 ottobre; in un’intervista rilasciata dopo la morte del papa, Bruck ha preso infatti le distanze dall’atteggiamento assunto da Francesco rispetto alla tragedia di Gaza.
Il rapporto con lo Stato d’Israele si è rivelato uno dei nodi in assoluto più complessi della parte finale del pontificato di Bergoglio. Lo è stato perché connesso prima al tema cruciale dell’atteggiamento da assumere nei confronti della guerra, e in secondo luogo tanto al rapporto tra antisionismo e antisemitismo quanto all’influsso dell’antigiudaismo cristiano sull’uno e sull’altro fenomeno.
Guerra e genocidio
Le prime fasi erano parse non laceranti. Già nel novembre 2023 un gruppo di studiosi e leader religiosi ebrei chiedeva alla Chiesa «di agire come faro di chiarezza morale e concettuale in mezzo a un oceano di disinformazione, distorsione e inganno; di distinguere tra legittima critica alla politica di Israele (…) e l’odiosa negazione di Israele e degli ebrei».3
La lettera riveste importanza soprattutto perché ricevette il 2 febbraio 2024 una risposta empatica da parte del papa; dopo aver constatato che questa guerra ha purtroppo prodotto nell’opinione pubblica mondiale anche forme di antisemitismo e di antigiudaismo, il pontefice ribadisce il rapporto «particolare e singolare» che lega la Chiesa al popolo ebraico, senza «mai oscurare, naturalmente, il rapporto che la Chiesa ha con gli altri».
Si rifiuta inoltre «ogni forma di antigiudaismo e di antisemitismo, condannando inequivocabilmente le manifestazioni di odio verso gli ebrei e l’ebraismo come un peccato contro Dio». Facendo memoria dell’incontro di preghiera per la pace svoltosi l’8 giugno 2014 nei Giardini vaticani alla presenza del presidente dello Stato d’Israele Shimon Peres, di quello dell’Autorità palestinese Abu Mazen e del patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, si invoca Dio come Padre e fonte della fratellanza umana, in quanto «la storia insegna che i nostri poteri non sono sufficienti. Più volte siamo stati sull’orlo della pace, ma il maligno, utilizzando diversi mezzi, è riuscito a bloccarla».4
Il continuo aggravarsi delle azioni belliche condotte dallo Stato d’Israele contro la popolazione di Gaza ha suscitato una crescente preoccupazione vaticana, che l’ha giudicata una reazione non proporzionata. Nell’anniversario del 7 ottobre papa Francesco inviò una lettera ai cattolici del Medio Oriente. Sono parole accorate in cui si parla di sangue, di lacrime e di voglia di vendetta: «Gli uomini oggi non sanno trovare la pace e noi cristiani non dobbiamo stancarci di chiederla a Dio. Perciò oggi ho invitato tutti a vivere una giornata di preghiera e digiuno. Preghiera e digiuno sono le armi dell’amore che cambiano la storia, le armi che sconfiggono il nostro unico vero nemico: lo spirito del male che fomenta la guerra, perché è “omicida fin da principio”, “menzognero e padre della menzogna” (Gv 8,44)».
La citazione giovannea aveva come immediato preludio le parole che hanno alimentato, forse più di ogni altra, l’antigiudaismo cristiano: «Voi avete come padre il diavolo» (Gv 8,44). L’accostamento ha irritato la componente ebraica più colta, che vi ha scorto il residuo di un atavico odio antiebraico.5 Ne costituirebbe una spia il fatto di denunciare soltanto Israele per comportamenti presenti, in forme ancora più gravi, in altri popoli.
La fase più acuta della tensione è toccata quando sul quotidiano La Stampa venne anticipato un passo tratto dal libro di papa Francesco, La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore (Piemme, Segrate [MI] 2024). Nel brano si legge: «A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali».
Nei mesi successivi si succedono appelli ininterrotti per la cessazione dei bombardamenti di cui è vittima una popolazione civile ridotta agli estremi. Si registrano da parte ebraica molteplici reazioni di segno fortemente critico. In occasione della celebrazione della Giornata per l’approfondimento del dialogo ebraico-cristiano del 17 gennaio 2025, il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni ha per esempio detto: «La condanna della guerra quando è monolaterale e monotematica è sospetta. Un pontefice non può dividere il mondo in figli e figliastri. E dunque deve denunciare le sofferenze di tutti».
Ancora più qualificanti le reazioni delle autorità israeliane, che hanno risolutamente respinto l’idea di un’indagine internazionale al riguardo. L’Ambasciata israeliana presso la Santa Sede, usando un’aggettivazione non casuale e a sua volta problematica, ha scritto che quella di Tel Aviv è autodifesa di fronte al «massacro genocida» del 7 ottobre. Definirla in altro modo «significa isolare lo Stato ebraico».6
Dopo la morte di Francesco, le sentite parole di condoglianza del presidente israeliano Herzog hanno trovato solo un tardivo e ridimensionato riscontro nelle comunicazioni governative. Inoltre, di fronte a una presenza quasi corale dei «potenti della terra», la delegazione israeliana ai funerali di papa Bergoglio è stata volutamente di profilo molto basso.
In conclusione, il ruolo svolto dallo Stato d’Israele nell’identità ebraica e quindi, di riflesso, nell’insieme del dialogo ebraico-cristiano è una delle questioni più delicate lasciate in eredità da papa Francesco al suo successore.
Piero Stefani
1 Una serie di colloqui tra il rabbino e l’allora arcivescovo di Buenos Aires su vari argomenti – Dio, il fondamentalismo, gli atei, la morte, la Shoah, l’omosessualità, il capitalismo – è stata raccolta in J.M. Bergoglio, A. Skorka, Il cielo e la terra, Mondadori, Milano 2013.
2 Cf. Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili (2015); Regno-att. 11,2015,734.
3 Regno-doc. 5,2024,190.
4 Ivi.
5 Cf. A. Gregerman, «Unfulfilled promise. Pope Francis and the Israel-Hamas war», in The Tablet 20.11.2024.
6 Avvenire 18.11.2024.