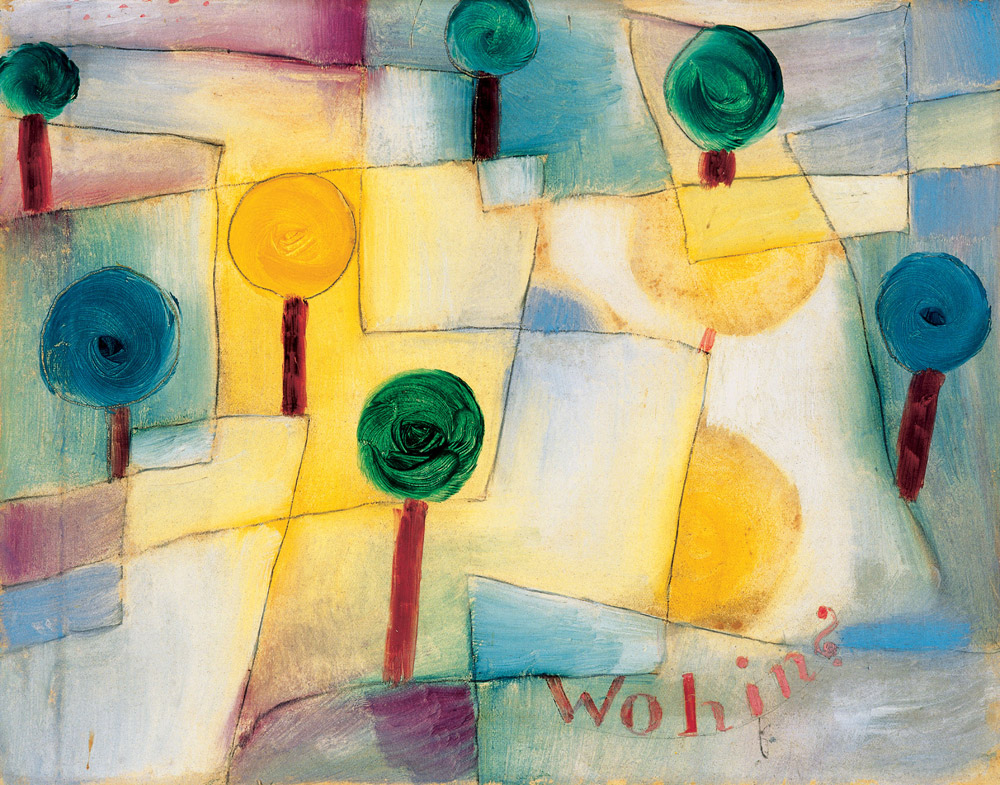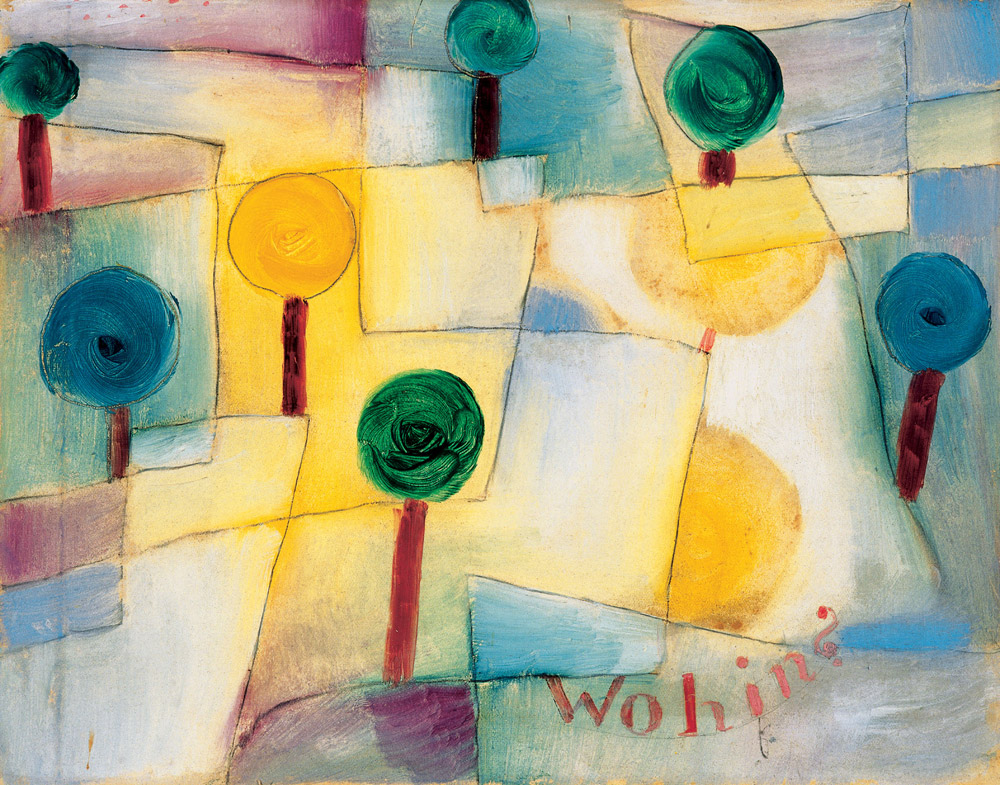Spes non confundit
Per la vita che verrà e per quella terrena

In der Hoffnung sein, «essere in speranza», è un’espressione tedesca per affermare d’essere incinta (cf. Regno-att. 4,2025,125s). È dato indiscutibile che Paolo di Tarso ignorasse la lingua di Goethe, tuttavia, quando parla dello sterile utero di Sara, si sarebbe quasi tentati d’ipotizzare che il modo di dire non gli fosse ignoto. È come se lo conoscesse per rovesciarlo al pari di un guanto. Abramo infatti credette «spes contra spem».
Il patriarca rimase saldo nella speranza e nella fede d’avere un figlio anche quando vedeva morto il suo corpo centenario e inaridito il già infecondo ventre di Sara. Di fronte alla promessa di Dio, Abramo non esitò e rafforzò la propria fede, convinto che giungesse a compimento quanto gli era stato annunciato (cf. Rm 4,18-22). Credette e sperò: fede e speranza si sostengono a vicenda.
Si spera non solo in quello che ancora non c’è, ma lo si fa rispetto a quanto in se stesso non ha alcuna potenzialità di realizzarsi. Allora ci si affida unicamente a una parola/promessa che viene dal di fuori.
L’impotenza della sterilità trova una corrispondenza ancor più radicale nella morte. L’accostamento è suggerito da Paolo stesso che pone sotto la cifra del morire i corpi decrepiti dei due coniugi. Il centro insostituibile della speranza cristiana è la resurrezione dei morti, esito che nessun defunto può raggiungere in base alle proprie forze. Quando si spera in questo modo ci si affida a un «altro» giunto a noi.
In virtù di questa presenza, lo sperare diviene la forma attuale in cui ci è dato partecipare alla salvezza: «Nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Nello sperare è insita una caparra della salvezza che, in virtù delle «primizie dello Spirito» (Rm 8,23), ci sospinge ad attestare che l’ultima parola non spetta alla vanità che ora estende il proprio dominio su ogni cosa.
Nella costituzione del nostro essere, così come siamo ora, nulla è in grado di valicare il muro della morte. Per sperare in questo «oltre» occorre essere in comunicazione con lo Spirito. La creazione di cui siamo parte è vittima di una disperazione oggettiva, nulla in essa ha la potenzialità di scavalcare la caducità che le è propria.
I nostri occhi vedono il venir meno mentre non scorgono l’«oltre» a cui è rivolta la speranza: «Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza (hypomone)» (Rm 8,24s).
Virtù messa alla prova
L’azione che nell’8o capitolo della Lettera ai Romani è attribuita alle «primizie dello Spirito», nel 5o è frutto dell’amore di Dio (genitivo soggettivo) riversato in noi in virtù del medesimo Spirito: «Per mezzo di lui [Gesù Cristo] abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza (hypomone), la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude [non svergogna; spes non confundit; nda], perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,2-5).
Il vantarsi è simmetrico al non essere svergognati di cui è garanzia la speranza. Si è in una circolarità. Si parte dall’essere «saldi nella speranza», tuttavia la speranza è anche frutto della pazienza-perseveranza (oggi diremmo forse della resilienza) e della capacità di reagire alla tribolazione. È la virtù messa alla prova a ricondurre infine di nuovo alla speranza.
La tribolazione di per sé non alimenta affatto lo sperare, a farlo è la capacità di restare saldi nella tribolazione. La speranza che non confonde non è travolta dalle distruttive tempeste dalla vita. In questo senso ne esce rafforzata.
Si ha speranza anche quando nel mondo del visibile nulla giustifica il fatto d’averla. Ciò, da sempre, suscita lo sconcerto o persino il sarcasmo di chi si sente un ergastolano racchiuso nella prigione della caducità. «Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» (1Pt 3,15s). «A rispondere», alla lettera suona «ad apologia».
Ciò implica che la domanda sia stata posta in tono aggressivo. Ci si misura con un’interrogazione rivolta per provocare e non già per comprendere. Il rispondere con dolcezza, rispetto e retta coscienza non è tratto accessorio, non è semplice buona educazione; al contrario, è una componente fondamentale consustanziale all’autentico sperare. Lo è non tanto (o almeno non solo) per volgere alla mitezza l’aggressività altrui, quanto perché attesta la «virtù provata» di rimanere fedeli alla parte di bene seminata in noi. Bisogna dar ragione della speranza che abita in noi. Va proposta l’apologia di quello che non è né un nostro prodotto, né un frutto delle nostre opere.
La speranza è intimamente anti-identitaria. Lungi dall’essere diretta ad attestare quanto siamo, essa, in virtù dello Spirito, è rivolta a quel che saremo: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è» (1Gv 3,2). Allora pure il semplice sguardo sarà trasformante.
Dar ragione della speranza
Siamo chiamati a dare ragione della speranza che è in noi. Non dobbiamo testimoniare noi stessi. Ciò non toglie che vivere in speranza sia un atto visibile e muti il modo in cui ci si pone davanti a Dio, al prossimo e a sé stessi.
La persona spiritualmente in speranza diviene riconoscibile pure a causa delle sue doglie: «Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo» (Rm 8,22s).
Avere le «primizie dello Spirito» equivale, metaforicamente, a essere gravidi. Esiste però una cifra di caducità universale in cui le doglie sono sperimentate anche quando non si è pregni. L’esperienza della vanità, quando è abbandonata a se stessa, è espressa da alcune parole di Isaia: «Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo vento» (Is 26,18). Unicamente lo Spirito attesta che l’estinguersi non è esito inevitabile.
Chi è in speranza diviene quindi riconoscibile nel suo vivere da pellegrino nel cuore dell’esistenza umana. Attualmente però a questo punto sorge una domanda, sollevata già, anni or sono, dalla compianta pastora luterana Almut Kramm: chi oggi ci chiede più di fare apologia della nostra speranza?1 Il passo della Prima lettera di Pietro è assai più citato che vissuto. Essere «pellegrini e ospiti» (1Pt 2,11) nell’esistenza è altra cosa dal compiere visibili pellegrinaggi giubilari.
La speranza autentica attesta che siamo forti solo quando siamo deboli: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo (…) infatti quando sono debole è allora che sono forte» (2Cor 12,9s). Sono versetti imparentati con il paradosso racchiuso nella formula liturgica che qualifica la croce come «spes unica». In noi non c’è alcuna forza in grado di vincere la morte.
Di nuovo e sempre ci è chiesto di testimoniare non la nostra identità di speranti, bensì la speranza che abita in noi. Si è di fronte a una specie di variante dell’espressione (non meno paradossale) presente nel profeta Zaccaria che, per indicare la liberazione dall’esilio, usa l’immagine d’essere «prigionieri della speranza» (Zc 9,12).
La speranza che è in noi ci costringe a sperare e in ciò muta il modo di vivere del credente. Paolo afferma che se abbiamo avuto speranza solo in questa vita siamo da commiserare più di tutti gli uomini (cf. 1Cor 15,19). L’Apostolo lo afferma in un capitolo tutto dedicato alla risurrezione dei morti. Senza tradire il messaggio rivolto all’attesa della vita del mondo che verrà, si può dichiarare che sperare nell’altra vita è anche un modo per vivere già ora una vita altra.
Il verbo sperare coniugato al presente esige di non appiattirsi in una supina accettazione dell’esistente, né di consegnarsi all’intrinseca caducità che lo attanaglia. «La vita altra» è prigioniera della speranza quando si rifiuta di concedere la parola ultima al male e alla morte (cf. 1Cor 15,26-28.54-58).2
1 A. Kramm, «“Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi” (Omelia su 1Pt 3,15)» in Aa. Vv., La speranza che non delude. Se tarda attendila perché presto verrà (Ab 2,3), a cura del Segretariato attività ecumeniche, Àncora, Milano 2005, 231.
2 e riflessioni contenute in questa puntata della rubrica «Parole delle religioni», e nella precedente (cf. Regno-att. 4,2025,125), derivano da una conversazione tenuta nel novembre 2024 presso la parrocchia San Camillo de Lellis di Chieti. La comunità parrocchiale, a cui questi due interventi sono dedicati, nel 2025 festeggia il 60o della sua istituzione.