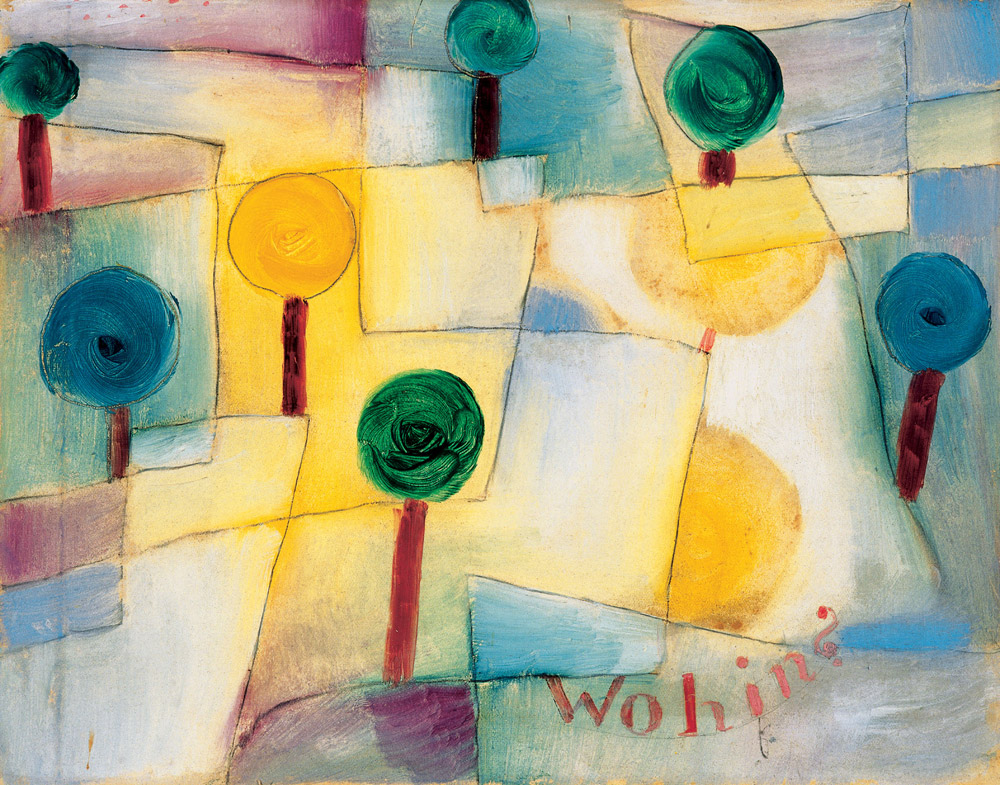Sperare, come?
Anche se c’è delusione, c’è salvezza

È una lunga storia che comincia da un versetto del profeta Isaia. Nell’attuale traduzione ufficiale cattolica suona così: «Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede non si turberà» (Is 28,16). Nel testo ebraico vi è il verbo hus che, in questo caso, potrebbe essere reso con «non sarà travolto». Dato che è salda, non c’è pericolo che la pietra vacilli e precipiti rovinosamente su qualcuno.
Il passo profetico fu caro a Paolo, che lo cita due volte nella Lettera ai Romani (9,33; 10,11; cf. 1Pt 2,6-8): la prima in senso negativo, riferita a coloro che hanno urtato contro la pietra di inciampo, la seconda in senso affermativo, per indicare la salvezza di chi crede. Paolo s’attiene alla traduzione giudeo-ellenistica dei Settanta; lo fa tanto in relazione al verbo impiegato (kataschyno), quanto per l’inserimento, tutt’altro che marginale, di un complemento oggetto: «Chi crede in lui» non sarà deluso. Ora quel «lui» è inteso in senso apertamente cristologico. Non è inutile precisare che il verbo greco ha, però, il senso più di venir svergognato, confutato, che quello di essere deluso; non a caso la Vulgata ricorre, opportunamente, al passivo di confundo («non confundetur», Rm 10,11).
Nella Lettera ai Romani il verbo kataschyno torna solo in un’altra occasione. Questa volta non si tratta di una citazione, tuttavia è ben possibile ipotizzare che Paolo avesse già in mente quel versetto. Si tratta di un passo destinato a rimanere all’ordine del giorno per tutto il resto dell’attuale anno giubilare: «La speranza non delude» (Rm 5,5). Delude o qualcosa di più e in parte diverso? «Spes autem non confundit», dice il latino. Qualunque sia la traduzione, rimane vero che, per affermare qualcosa di positivo, si fa ricorso a una negazione.
Per analogia, viene in mente la parola «nonviolenza»; la scelta di scriverla attaccata non esorcizza il fatto che il termine conglobi un «non». «Non delude» implica che la speranza sia esposta al concreto rischio di essere confutata. In realtà, a ben pensarci, è la delusione a nascere dalla speranza e non viceversa. Si rimane delusi o addirittura svergognati se si è posta la propria fiducia in una possibilità futura che non è mai divenuta realtà.
Chi nulla attende, nulla patisce; o meglio è soggetto unicamente alla tiepida ignavia di un’indifferenza da lui, per lo più, neppure avvertita. La delusione implica la memoria di una speranza frustrata; è uno stato d’animo alimentato dal ricordo. La speranza, per sua natura, anche quando ha radici, guarda in avanti. Solca il mare del possibile, ed è per questo che non le sono ignoti i naufragi. Il verbo «sperare» coniugato al passato è sigillo della delusione. Nel loro scoramento i discepoli di Emmaus esclamarono: «Noi speravamo» (Lc 24,21).
Giorno dopo giorno, davanti a noi si estende il gran mare del possibile. È parola antica (la si trova nell’Edipo re) quella secondo cui nessuno va dichiarato felice prima del giorno della sua morte. Che cosa ci riserverà il futuro? Nell’orizzonte esistenziale non si è in grado di rispondere a questa domanda. Siamo in balìa delle onde dell’avvenire.
L’atto di sperare non garantisce di per sé che il futuro sia conforme ai nostri desideri. L’esito atteso non è né una semplice produzione della nostra volontà, né puro frutto del nostro agire. L’illusione e il restar delusi formano il dritto e il rovescio del medesimo tappeto. Quando si pone speranza in ciò che non ha fondamento (illusione) si spalancano, senza saperlo, le porte alla delusione. Nella sua fragilità, la speranza è un bene che può assumere gli oscuri panni del male.
Educati a sperare
L’ambivalenza è iscritta anche nel mito di Pandora. Zeus riempie il vaso di tutti i mali e comanda di non aprirlo. La curiosità induce a disobbedire all’ordine. L’esito dell’atto è nefasto, tutti i mali cominciano a dilagare per il mondo. Si cerca d’attuare contromisure e il vaso viene precipitosamente chiuso quando ormai è quasi completamente vuoto, salvo il fatto che nel suo fondo resta la speranza.
Da qui sorge un interrogativo (avanzato anche da Jürgen Moltmann): la speranza è un modo per sopportare i mali (malattia, vecchiaia, sventure ecc.) o è anch’essa un male mascherato da bene? Il vaso, in partenza, non conteneva forse solo mali?
Kierkegaard ha definito la speranza «la passione del possibile». Nel possibile tutto è possibile, il sì come il no. La passione è una specie di corpo a corpo nei confronti di quel che può accadere. Ciò vale, sub contraria specie, anche per la paura, stato d’animo alimentato dal timore che forse, al nostro riguardo, avranno luogo eventi dannosi.
Per quanto possa essere anche solo questione di istanti, è inoppugnabile che la paura si dia unicamente rispetto al futuro. Dal canto suo, la disperazione consiste nella profonda e devastante convinzione soggettiva che, inevitabilmente, il negativo si realizzerà. La passione per il possibile sta nel credere che ci sia una via d’uscita anche quando la situazione sembra ad altri (e forse persino alla parte più fragile di noi stessi) senza speranza. L’oggetto dello sperare riguarda l’avvenire, mentre l’atto di sperare (o disperare) attiene al presente.
Se l’espressione «speravo che…» è sigla della delusione, la frase «spererò che…» è quasi inimmaginabile. Tuttavia, lo sperare coniugato al presente è messo al riparo dall’illusione solo se si basa su una pietra angolare saldamente fondata. Per dare sostanza allo sperare, occorre appoggiarsi su qualcosa o qualcuno che ci precede.
In der Hoffnung sein («essere in speranza») è la toccante espressione tedesca per affermare d’essere incinta. Qualcosa, anzi qualcuno c’è già, ma egli deve completarsi, crescere, venire alla luce. Si tratta di un processo che dipende solo in parte dalla volontà della madre. La situazione è paragonabile a quella del seme che, per diventare pianta, attende di spuntare. Il coltivatore se ne prende cura, ma non basta quest’ultima operazione a farlo crescere. Il suo sviluppo è in mano a quel che, per mancanza di termini migliori, chiamiamo natura.
L’«essere in speranza» ha però anche un risvolto oscuro, il processo può abortire, nel senso letterale o metaforico del termine: «Giù non basta buon cominciamento / dal nascer de la quercia al far la ghianda» (Divina commedia, Paradiso, XXII, 86s). Nel possibile tutto è possibile. Con tutto ciò non è fuorviante sostenere che, rispetto al nostro essere, la speranza ci precede. Noi tutti, infatti, siamo stati ospitati nell’utero di nostra madre restata in speranza per nove mesi.
Ciò avviene perché siamo costituiti da relazioni che ci legano con chi è altro da noi. Un profondo, enigmatico detto di Walter Benjamin afferma: «Coloro per i quali ci è data speranza, sono quelli senza speranza (Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben). La frase è estrema, ma è anche certo che tutti noi speriamo perché altri hanno già sperato. L’affermazione, particolarmente vera per le tradizioni religiose, vale anche per altri contesti, a iniziare da quelli culturali e politici. Si spera perché si è stati educati a sperare.
La speranza implica i legami
L’atto di sperare trova un suo fondamento quando, attraverso il ponte dell’impegno presente, congiunge la memoria all’attesa. All’inizio della Haggadah di Pesah (il testo recitato nel corso della cena pasquale ebraica) si alza il vassoio delle azzime e si pronuncia questa formula: «“Questo è il pane dell’afflizione che i nostri padri mangiarono in terra d’Israele” (Dt 16,3), chi ha fame venga e mangi, chi ha bisogno venga e faccia pasqua. Quest’anno qui, l’anno venturo in terra d’Israele; quest’anno qui schiavi, l’anno venturo in terra d’Israele liberi».
S’inizia con la memoria della passata schiavitù, si conclude con l’apertura rivolta al prossimo irrompere della libertà; l’una e l’altra dimensione, però, trovano senso e consistenza soltanto se c’è un presente ospitale e soccorrevole. Tiqwah, speranza in ebraico, è un termine dotato di una parentela semantica con qaw, «corda». Lo sperare implica l’esistenza di legami. Noi speriamo perché altri hanno sperato. Tuttavia è vero anche il contrario, siamo delusi, affranti o addirittura disperati se conserviamo memoria di speranze sempre riproposte e mai realizzate.
Sia pur messa in bocca ai falsi maestri, il Nuovo Testamento conosce la provocazione connessa alla promessa disattesa: «Dov’è la sua venuta, che egli ha promesso? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione» (2Pt 3,4). Se non si avesse memoria di quanto promesso, ci sarebbe solo l’indifferenza del presente.
La speranza non si sottrare all’ambivalenza. Da un lato, essa si fonda su quello che c’è; il presente (secondo il detto di Leibniz) è gravido dell’avvenire, mentre, dall’altro, coglie la miseria dell’esistente. Occorre far tesoro delle potenzialità attuali, eppure lo sperare comporta sempre anche un giudizio critico sulle realtà presenti, ne rivela le crepe, ne smaschera le fragilità, ne denuncia le insufficienze.
La situazione odierna, sia essa individuale o collettiva, non è mai esente da opacità. Se la realtà fosse bloccata allo stato attuale, l’ombra della mancata realizzazione prevarrebbe sulla luce delle virtualità iscritte nel reale. La speranza che non delude si fonda, oltre che sull’esistente, anche e soprattutto su quanto ancora non c’è.
Si tratta di una realtà che viene a noi, molto più di quanto noi andiamo a lei. Siamo stati salvati nella speranza (cf. Rm 8,24).