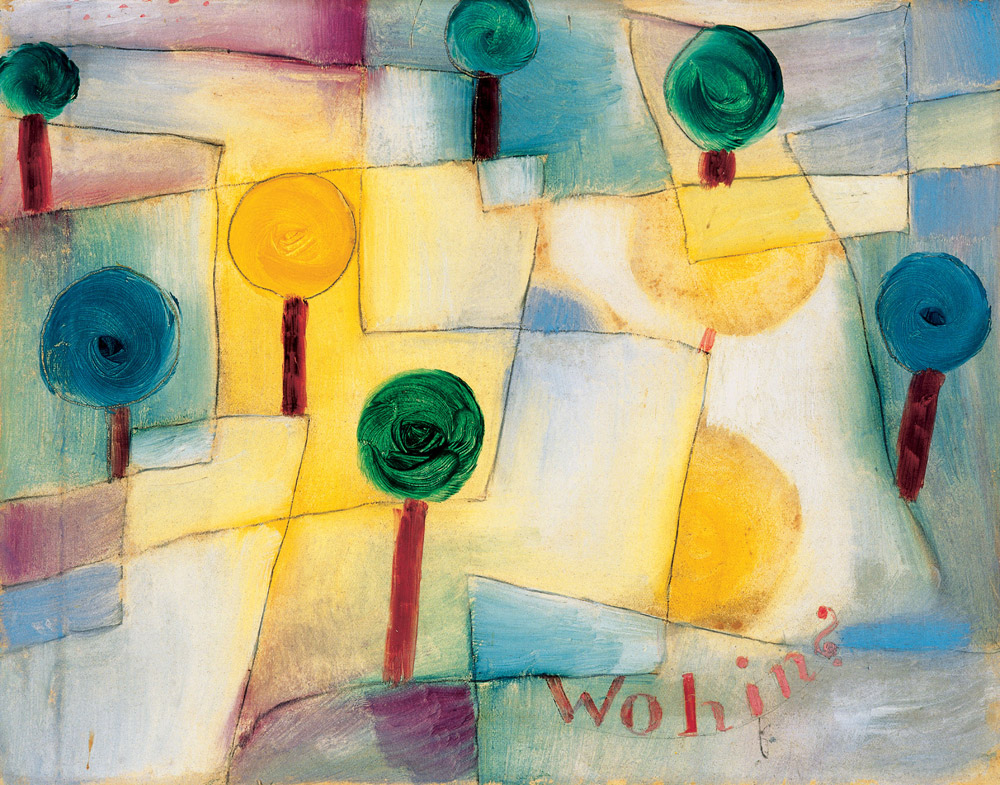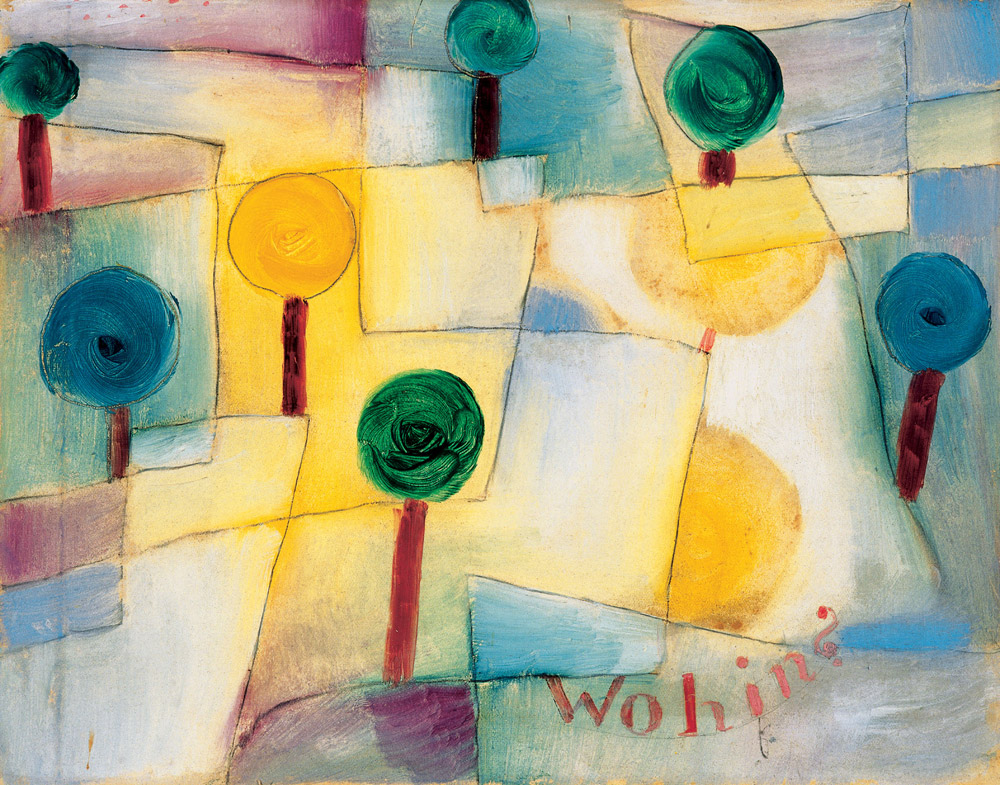Il nemico sconfitto
Marcel Marceau e Liana Millu

Marcel Marceau, il più grande mimo del Novecento, apparteneva a una famiglia ebraica: per l’anagrafe il suo cognome era Mangel. Nella sua autobiografia racconta che nel dicembre del 1945, quando aveva 22 anni, s’arruolò nella 1a Armata che si unì alle truppe di occupazione di stanza in Germania. Marceau, impegnato nella Resistenza, allora non aveva ancora la certezza assoluta su quale fosse la sorte di suo padre deportato dai nazisti.
Giorno dopo giorno, l’esito infausto diveniva però sempre più certo. Subito dopo la Liberazione e anche in anni successivi, Marceau sognava, a volte, il ritorno di suo padre. Lo vedeva su un tram, per strada, racconta d’averlo scorto seduto in uno scompartimento che lo guardava senza vederlo. Si svegliava madido di sudore, se si riaddormentava il sogno riprendeva.
L’esperienza onirica è accostabile, per antitesi, a quella che, anni dopo, faceva Rudolf, un figlio di un alto gerarca nazista, tutt’altro che pentito. La famiglia aveva trovato un rifugio sicuro, anzi confortevole, in Argentina. Il figlio faceva un sogno ricorrente: era portato via da degli ebrei che indossavano una giacca a righe. Trasportato in auto attraverso una folla festante, veniva infine rinchiuso in una stanza munita di finte docce da dove usciva quel che sappiamo. Si precipitava alla porta, che cercava invano di apire, gridava, gli bruciavano gli occhi. Finalmente si svegliava e non dormiva più. Se avesse ripreso sonno si sarebbe ripresentato lo stesso sogno.
Il subconscio opera diversamente se la sorte ti consegna a essere dalla parte delle vittime o figlio dei carnefici.
Marceau restò in Germania fino alla primavera del 1946. Si domandò, più volte, in che modo doveva guardare ai tedeschi. Fu sorpreso dalla loro mancanza di aggressività. Passava per città e villaggi semideserti: c’erano solo donne e bambini. Lui, al pari di tanti altri, aveva talmente sofferto a causa dei tedeschi, che pensava che il suo odio sarebbe esploso. Imparò invece che si possiede odio solo nell’ardore del combattimento. In terra tedesca i soldati non trovarono alcuna resistenza; c’era una passività, una sottomissione totale che gli procurava nausea. Nella Germania occupata non incontrò un solo nazista. Era come se tutta la nazione non fosse a conoscenza della tragedia che era appena successa. Ebbe più volte la sensazione che, gira e rigira, quello che i tedeschi rimproveravano a Hitler era di aver perso la guerra.
Comprensione ma anche giudizio
È difficile covare l’odio, prosegue Marceau, quando non si è stati educati ad averlo. Gli mancava la forza morale d’umiliare il nemico sconfitto. Era a terra e non intendeva calpestarlo. I tedeschi soffrivano di un complesso di colpa. Tutti quelli con cui parlò erano felici che la guerra fosse finita e giuravano che non sarebbero stati mai più ingannati dalla propaganda. Fu solo più tardi, quando la Germania si riprese economicamente, che alcuni manifestarono di nuovo l’arroganza che gli aveva fatto capire che gli assassini sono ancora tra noi. Oggi, 2025, l’anagrafe ha risolto il problema rispetto alle persone, ma le sue armi, a quanto sembra, sono spuntate rispetto all’ideologia che mostra inquietanti rigogli.
Marceau sottolinea che centinaia di migliaia di tedeschi avevano sofferto sotto il nazismo. Molti di loro erano morti nei campi di concentramento: comunisti, devoti cattolici o socialdemocratici. Ma gli altri? I complici del regime, i funzionari che ricevevano ordini, gli architetti che progettavano bunker e campi di concentramento, i chimici che preparavano i gas e così via, come potevano commuoversi alla morte di Papillon? Al termine di un suo mimo in cui moriva una farfalla, papillon appunto, Marceau vedeva il pubblico con gli occhi lucidi.
Chi può escludere che tra loro ci fossero degli attivi collaboratori del regime nazista? Avere subìto dei danni di enorme portata non cancella con un colpo di spugna le ingiustizie commesse. Tuttavia, si può aggiungere, non occorre essere psicologi provetti per sapere che l’animo umano è in grado di contenere gli opposti senza che tra essi sussista alcuna sintesi. Fatto che sconcerta allorché lo si osserva negli altri, meno quando lo si intravvede in noi stessi, forse perché allora, troppo spesso, si alzano le cortine fumogene della nostra viltà morale.
In conclusione, Marceau riassunse la sua esperienza tedesca dicendo d’aver capito che le uniche ragioni valide per vivere sono: la dignità umana, il rispetto per gli altri, la rieducazione degli uomini, la consapevolezza, la ricerca di prove sull’aberrazione mentale. Quest’ultima osservazione, la più inattesa, attesta l’urgenza del perenne compito etico d’attuare un discernimento in grado di proporre una comprensione non scevra dal giudizio.
L’astrazione facilita l’odio
Il 6 febbraio di vent’anni fa moriva Liana Millu (cf. Regno-att. 22,2004,734; 4,2005,138), scrittrice e testimone capace di dar voce alle donne di Birkenau che, a differenza di lei, non hanno fatto ritorno. Nell’autunno del 1944 fu trasferita a Malchow, un sottocampo di Ravensbrück. Nel maggio del 1945, appena libera, trovò in una fattoria abbandonata un diario in bianco; accanto a esso c’era un mozzicone di matita. Scrivere era sempre stata la sua passione. Da quel giorno fino a quando, ai primi di settembre, varcò il confine italiano, riempì le pagine di dati di cronaca, di immagini, di riflessioni, dei primi appunti per quanto desiderava redigere in seguito. Se ci fu mediazione letteraria, fu istantanea e diretta pensando a se stessa e non già a un ipotetico pubblico. Alla vista del nemico sconfitto, la riflessione personale si fece etica.
Si è di fronte a una descrizione che sfocia in un profondo dialogo interiore che è obbligo riportare nella sua interezza: «Verden (Germania) 8 luglio1945. Ah, ecco volevo dire la scena della stazione. Il piccolo atrio è pieno di giovanotti ebrei, robusti, ingrassati, dall’aria sicura; un polacco dal viso torvo, la coccarda bianco-rossa all’occhiello, stivaloni insolenti, discorre con loro, passeggiando su e giù. E in un angolo, vicino alla biglietteria, un soldato tedesco. È giovane, potrà avere poco più di venti anni. È alto, quadrato, con un viso roseo e rotondo, ma di una rotondità che tradisce ora lo smagrimento, uno di quei visi che nei tempi orgogliosi giravano pieni di primitiva arroganza. L’uniforme è ingrinzita, sporca, gli stivali rotti e impolverati, accanto a lui un grosso sacco adattato a zaino con due pezzi di fune; si appoggia a un bastoncino fatto col ramo fresco di un albero. È in tutta la sua persona, nell’abito come nel corpo, la stanchezza greve della disfatta, quasi uno sbalordimento doloroso come di uno che all’improvviso si sia risvegliato in un amarissimo mondo e ne rimanga schiacciato ma non ancora convinto. Gli altri non si curano di lui ma egli non si muove, solo di tanto in tanto, senza rialzare la testa, getta su loro lo sguardo sfuggente di una bestia catturata e impaurita, lo sguardo del cane che aspetta il colpo. Lentamente si avvicina allo sportello, prende il biglietto, rimette con cura nella tasca rigonfia il fazzoletto dove ha avvolto il denaro. Prende il sacco, con sforzo se lo adatta sulle spalle e col bastoncino in mano si avvia all’uscita, cercando un passaggio tra il gruppo dei vincitori; scompare, un po’ curvo.
E io penso: odio quest’uomo? Potrei, se non io direttamente, godere nel vederlo maltrattare, nel vederlo umiliare? Penso e mi dico: “lui” no. Uno no. Perché quest’uno posso osservarlo e comprenderne l’infinita stanchezza, l’infinita umiliazione, persino la bestiale paura. Per me latina una creatura umana non potrà diventare mai un pezzo, uno “Stück”. Per condannarli dovrebbero essere molti, diventare cioè astrazione. E le astrazioni si possono condannare e odiare con indifferenza o con piacere».
Si odiano le astrazioni. Gli antisemiti sono ossessionati dal singolare. Parlano sempre dell’ebreo, tuttavia quando giungono a uccidere, ammazzano persone. Sterminano ebree ed ebrei in carne e ossa, e mai l’ebreo. Ciò è tragicamente vero, anche nel caso in cui non si giunga al genocidio, per ogni identificazione astratta e collettiva. Quando la persona è identificata, dall’esterno, con il gruppo a cui appartiene, l’ostilità, almeno psicologica, l’ha ormai avuta vinta. Lo sguardo che suscita comprensione rivolto a una determinata persona è antidoto alla violenza che, non a caso, definiamo cieca. Il riferimento a un singolo individuo non esorcizza tutto; esistono, lo sappiamo, anche violenze dirette a colpire uno specifico essere umano. Ciò non toglie, però, che sono soprattutto le astrazioni ad alimentare gli odi collettivi tuttora così diffusi sulla superficie del nostro errabondo pianeta.