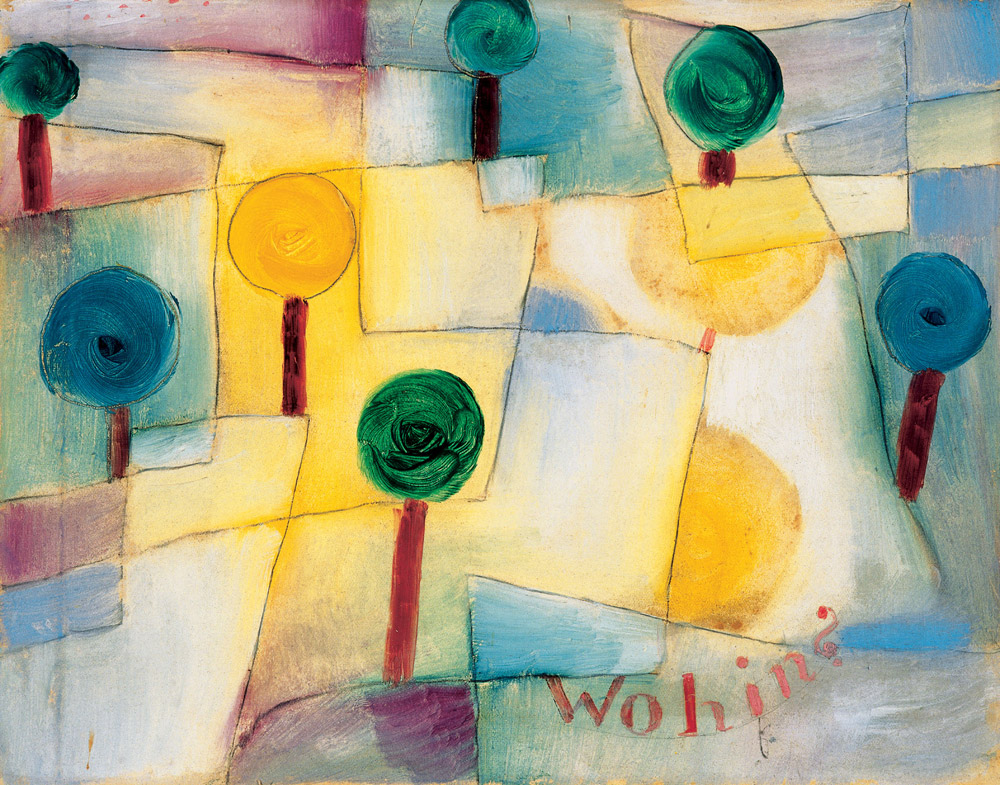Il lascito d’Israele
I sogni non passano in eredità
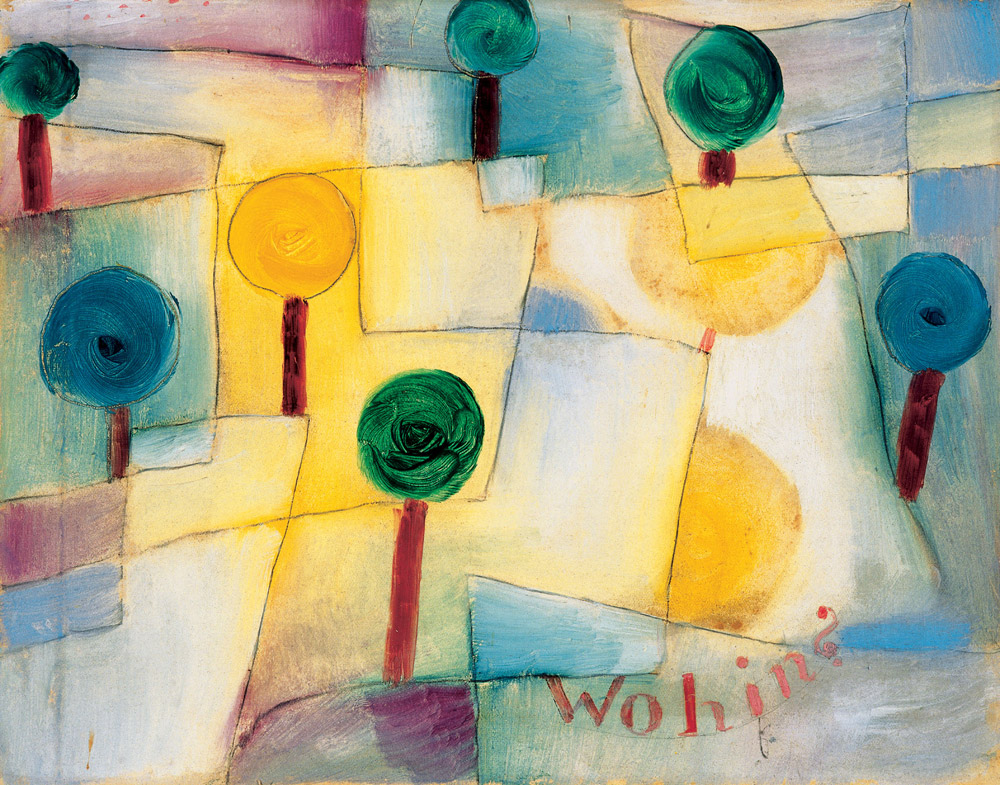
Autori ed editori sanno che non è facile trovare dei bei titoli. In realtà, quando la prova del tempo rende «classici» determinati libri, il problema si dissolve. I promessi sposi non è di per sé un titolo migliore dei precedenti Gli sposi promessi o Fermo e Lucia; tuttavia il rilievo, ormai, conta poco. Il romanzo di Manzoni si è sbarazzato di questioni legate alla titolazione.
Le cose stanno quasi all’opposto per altri testi. A volte, infatti, i titoli viaggiano per conto loro fino a diventare modi di dire separati dai contenuti specifici dei singoli libri (non di rado neppure letti). Sono dinamiche presenti sia in letteratura (La commedia umana, Alla ricerca del tempo perduto, On the road, La vita agra, Il male oscuro, L’insostenibile leggerezza dell’essere…) sia nella saggistica (Il tramonto dell’Occidente, L’uomo a una dimensione, Il grande codice, La fine della storia…).
Esiste un’ulteriore possibilità: ci sono testi poco conosciuti contraddistinti da titoli in grado d’esprimere realtà più vaste del loro tema peculiare. In questo novero rientra il libro di Corrado Israel De Benedetti, I sogni non passano in eredità.1
Sulle prime l’espressione evoca la difficoltà di trasmettere determinati ideali nel succedersi delle generazioni. Percezione corroborata dall’attuale valutazione positiva attribuita, in genere, al termine «sogno», ormai applicato persino a chi non s’addormenta e non dorme al fine di custodire Israele (cf. Sal 121,4).
Tuttavia va dato conto di un presupposto precedente; prima di parlare d’eredità, occorre che il sogno si prolunghi per l’intero corso della vita del sognatore. Molte volte ciò non avviene. In questi casi la disillusione equivale a cogliere, più o meno amaramente, la distanza che separa la labilità onirica da un solido progetto. Non pochi di coloro che nel Sessantotto ritenevano che il potere spettasse all’immaginazione, si sono trovati nelle condizioni di non essere, in prima persona, eredi dei propri sogni. A volte, sul piano esistenziale, le conseguenze sono state devastanti.
Il libro di De Benedetti si riferisce a una realtà specifica, quella del kibbuz. L’esperienza del villaggio retto da una visione democratica e collettivistica rappresenta, da tempo, un capitolo particolare della più ampia crisi del socialismo. Sorto assai prima della nascita dello Stato d’Israele (Degania Alef, risale al 1910), il movimento kibbuzistico è stato percorso da orientamenti diversi ed è passato attraverso fasi differenti: dall’egemonia esclusiva dell’agricoltura all’apertura al manufatturiero e, più di recente, al turismo e all’high tech.
Accentuate modifiche si sono registrate pure nelle modalità della gestione del lavoro (ormai è diffusa la presenza di salariati anche non ebrei) e nelle prassi tanto finanziarie quanto educative. Nel 2010 i kibbuzim in Israele erano 270, la loro popolazione complessiva ammontava a 126.000 persone. Resta indubbio che, tra le tante esperienze di villaggi collettivistici messi in opera a partire dal XIX secolo, solo quella del kibbuz, per quanto perennemente sfidata da una serie di difficoltà, si è rivelata duratura.
L’esperienza del kibbuz
Nel 1950 Martin Buber rivendicò, da un lato, l’esistenza di realizzazioni altrove rivelatesi effimere, mentre, dall’altro, si mostrò già consapevole di un senso di crisi che lo costringeva a coniugare al passato alcune delle sue considerazioni: «C’erano tanti sogni, e di vario genere, sull’avvenire: si guardava a una più ampia forma di famiglia, ci si sentiva l’avanguardia del movimento operaio, ci si sentiva anzi l’immediata realizzazione del socialismo, il prototipo della nuova società, ci si prefiggeva la creazione di un nuovo essere umano e di un mondo nuovo».2
Si ebbe, tuttavia, pure la capacità di non incapsularsi in uno schema rigido. Soprattutto, dietro la situazione palestinese – proseguiva Buber – c’era la condizione di un popolo tormentato da una grave crisi esterna alla quale reagì grazie a un grande mutamento interno. Da allora sono passati quasi 75 anni.
Su scala globale, di kibbuzim si è sentito di nuovo, tragicamente, parlare a partire dal 7 ottobre 2023. I due nomi di riferimento sono quelli di Kfar Aza e di Be’eri. Le vicende di quest’ultimo kibbuz, fondato nel Negev il 6 ottobre 1946, evidenziano molte componenti sul piano della cronaca, della storia, dei sogni e delle loro atroci smentite.
Bret Stephens ha scritto sul New York Times (10.11.2023) che Be’eri era nota per il suo orientamento a favore della pace, per la presenza di un fondo finanziario speciale per gli abitanti della vicina Gaza che arrivavano nel kibbuz con un permesso di lavoro e per la presenza di volontari disposti a trasportare palestinesi malati di cancro in centri oncologici ubicati a Sud d’Israele. Nel 2022 Be’eri contava 1.071 abitanti; in base alla prima provvisoria registrazione, le vittime del 7 ottobre sono state 108; in seguito il totale è diventato non meno di 130. Il giorno precedente, quando ricorreva il 70o anniversario della fondazione, nel kibbuz nessuno poteva immaginarselo.
Per una persona, un’associazione, un’istituzione, la scelta del nome è qualificante. Be’eri è giunto a indicare quel kibbuz attraverso varie mediazioni culturali. Il fatto che il padre di Osea portasse quel nome di per sé non dice molto (cf. Os 1,1). In verità la tradizione rabbinica considera anche Be’eri un profeta, ma così conciso nel suo dire da far sì che la sua unica sentenza sia stata conglobata entro il libro di Isaia (cf. 8,19s). Niente si può ricavare dal fatto che il suocero ittita di Esaù portasse quel nome (cf. Gen 26,34).
Già più indicativo è guardare all’etimo: da be’er «pozzo, fonte, sorgente». Per trovare il bandolo della matassa occorre però rivolgersi a Berl Katznelson (1887-1944), ideologo del sionismo laburista (indirizzo che diede un contributo fondamentale alla nascita dello Stato d’Israele nel 1948) e direttore di Davar («parola, fatto, evento»), il primo quotidiano del movimento operaio nello Yishuv (insediamento ebraico nella Palestina mandataria). Be’eri era il suo nom de plume. Il kibbuz è dedicato a lui.
La soluzione dei due Stati
Berl Katznelson è, in parte, riconducibile alla linea sionista che si rifaceva alla matrice biblica anche per reagire all’egemonia diasporica goduta dal Talmud. Pensando alla storia ancor più che alla terra, Be’eri nel 1940 scrisse parole tuttora condivisibili da parte di altri gruppi o persone che vivono momenti difficili: «E io mi rivolgo alla Bibbia, a questo libro sempre attuale, in particolare ai nostri giorni. Quest’opera della fede non nasconde affatto lo smarrimento e non se ne difende. Geremia, portavoce della fede, si rivolge a Dio e s’arrabbia furiosamente: perché il successo arride ai malvagi? Non è questa l’espressione stessa dello smarrimento, innegabile all’epoca come oggi, nell’era di quella canaglia di Hitler? La Bibbia non elude la domanda e non le trova scuse».3 Allora la «canaglia» si trovava in Europa.
Katznelson rifiutò fermamente la prospettiva secondo la quale la realizzazione sionista fosse destinata a sfociare nella costituzione di una specie di «stato polacco» in cui gli arabi avrebbero occupato il posto degli ebrei e gli ebrei quello dei polacchi.4 Non avrebbe dovuto esserci alcuna subalternità.
Uno dei modi per non essere soggiogati è quello di venir divisi. Katznelson caldeggiò questa ipotesi. Nel 1937 in un congresso del Mapai (Partito dei lavoratori di Erez Israel fondato da Ben Gurion) sostenne che il trasferimento della popolazione era un motivo di discussione all’interno del partito: era consentito o vietato? Be’eri rispose: «Un vicino lontano è meglio di un nemico vicino. Loro non perderanno dal trasferimento e certamente non perderemo noi (…) Da tempo sono dell’opinione che questa sia la migliore di tutte le soluzioni». Più che nei dintorni di Nablus, gli abitanti autoctoni della Palestina avrebbero dovuto essere trasferiti in Siria e in Iraq.5 I sogni di convivenza stavano svanendo già allora.
«Noi abbiamo un ideale, noi abbiamo una missione, che sono la nostra ragion d’essere (…) il mondo ci giudicherà a seconda dei valori morali e spirituali che sorgeranno dallo sviluppo di questo paese e di questo popolo». La frase è di Moshe Sharett.6 André Chouraqui, propugnatore del dialogo interreligioso e traduttore in francese della Bibbia ebraica, del Nuovo Testamento e del Corano, la riporta nella Conclusione di un suo libretto del 1958.7
I tempi nei quali venne espressa questa opinione sono ormai lontani; di contro, la costatazione che lo Stato di Israele sia soggetto al giudizio del mondo è fatto più che mai attuale.
1 C.I. De Benedetti, I sogni non passano in eredità. Cinquanta anni di vita in kibbuz, Giuntina, Firenze 2001.
2 M. Buber, Sentieri in utopia. Sulla comunità, a cura di D. Di Cesare, Marietti 1820, Genova 2009, 187.
3 Cit. in G. Bensoussan, Il sionismo. Una storia politica e intellettuale 1860-1940, vol. 2, Einaudi, Torino 2007, 1050.
4 A. Cohen, Israel and the Arab World, Funk & Wagnalls Co., New York 1970, 260s.
5 I. Shahak, «A History of the Concept of “Transfer” in Zionism», in Journal of Palestine Studies 18(1989) 3, 22-37.
6 Ministro degli Esteri dal 1948 al 1955 e primo ministro d’Israele dal 1953 al 1955.
7 A. Chouraqui, Lo Stato d’Israele, Garzanti, Milano 1958, 121.