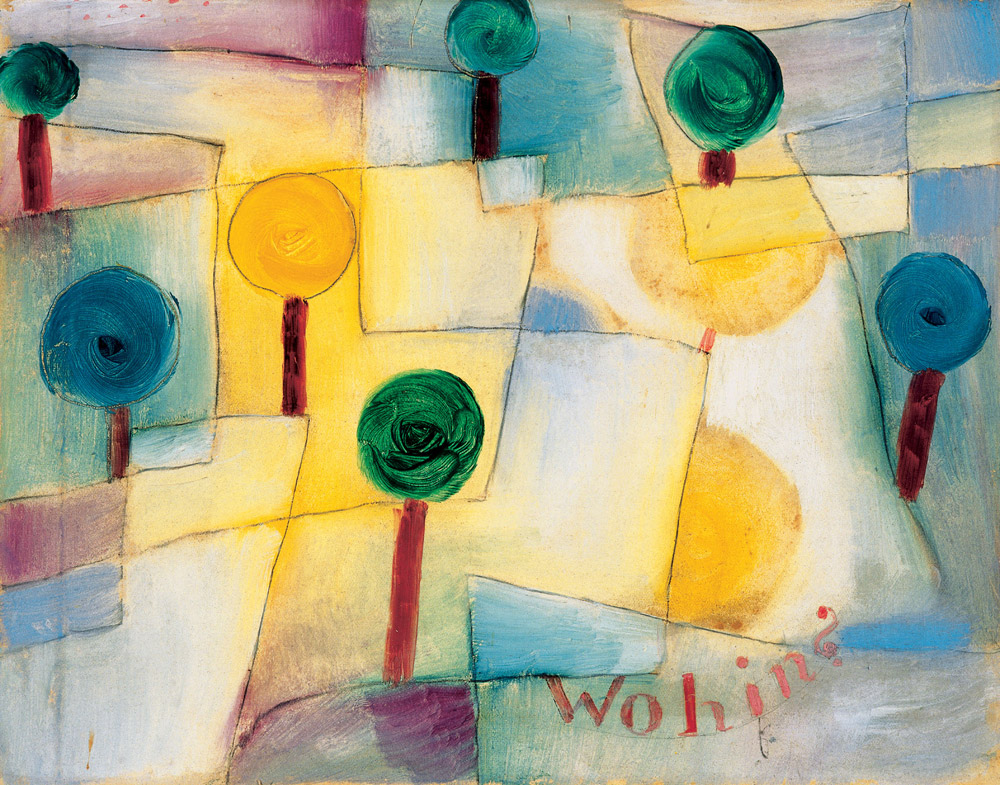Dignità e risarcimenti
L’evoluzione di un concetto
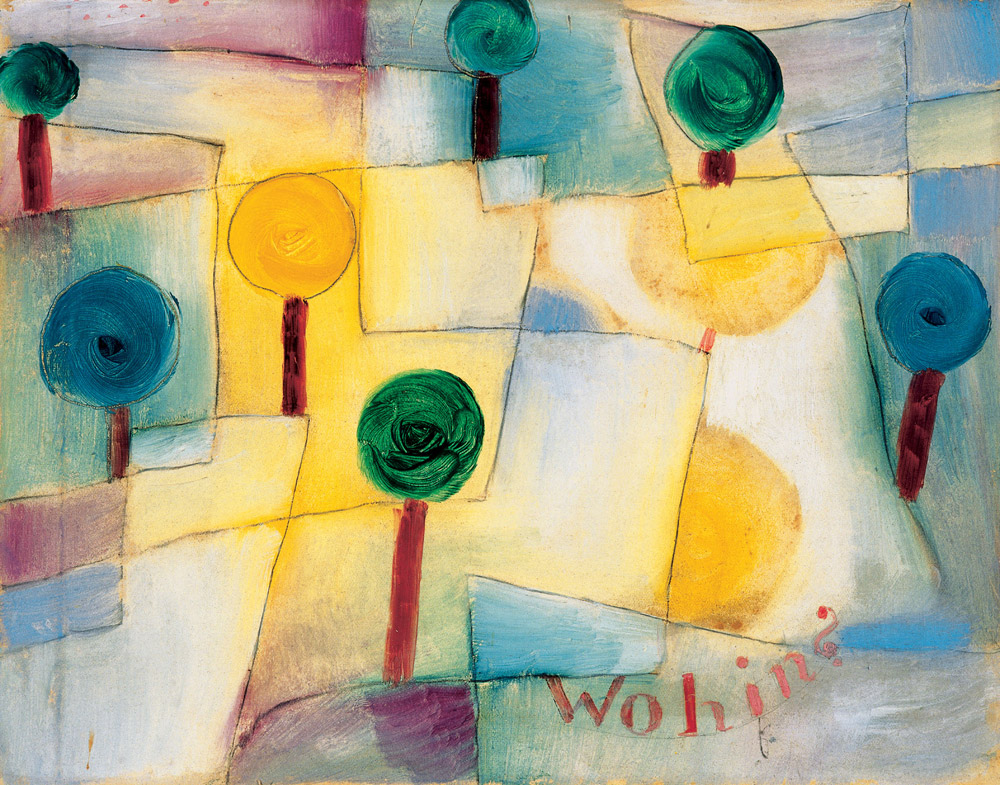
Presentando l’8 aprile scorso la dichiarazione del Dicastero per la dottrina della fede Dignitas infinita circa la dignità umana, il prefetto card. Víctor Manuel Fernández ha richiamato alcuni passi biblici non contenuti nel testo. Nel suo procedere si dà opportunamente per scontato il brano fondativo (citato, com’è ovvio, nel documento) in cui l’essere umano, maschio e femmina, è creato a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1,26s).
Con uno spirito caratteristico dell’attuale pontificato, lo sguardo della presentazione si rivolge, da un lato, alle persone emarginate o portatrici di handicap e, dall’altro, verso i modi di comportarsi nei loro confronti. S’inizia, infatti, citando il versetto del Levitico (19,14) che comanda di non porre un ostacolo davanti al cieco e di non maledire il sordo. Percepiamo, s’aggiunge, la tenerezza con cui si parla della dignità di queste due persone. «Non importa se questi mi ascolta, mi veda o no, anche se le mie parole non possono ferirlo non lo insulto per un profondo rispetto di fronte alla sua dignità».
La situazione, occorre aggiungere, è, se letta su questo piano, asimmetrica: la maledizione del sordo non è udita da quest’ultimo, egli, soggettivamente, non subisce danni; tutt’altro il discorso in relazione al cieco la cui menomazione lo espone a potenziali insidie. Chi maledice e architetta tranelli a scapito dell’inferiorità altrui non perde la propria «dignità ontologica» (espressione usata dal documento) ma, di certo, sminuisce gravemente quella etica. Tuttavia all’origine il testo poteva avere probabilmente tutt’altro significato. Sordo e cieco erano in una situazione simile. La maledizione va considerata efficace e il sordo non era in grado di prendere delle contromisure contro di essa proprio perché non l’udiva.
Il card. Fernández prosegue parlando del cieco evangelico; privo di vista ma dotato di parola, grida: «Gesù, abbi pietà di me». Si cerca di tacitarlo perché non disturbi più il Maestro (cf. Mt 20,29-34; Mc 10,46-52; Lc 18,35-43). «Quel tipo di persona non aveva alcun valore in quel momento, dava solo fastidio. Ma Gesù, ammutoliti i suoi discepoli, andò direttamente dal cieco e gli disse: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”. È una domanda carica di umanità, un gesto che parla di dignità riconosciuta».
Gesù lo fa, innanzitutto, perché gli rivolge la parola. Nel caso del cieco si palesa un frammento dialogico non sempre racchiuso nel puro atto di prestare aiuto (nella parabola del buon samaritano non avviene, per esempio, alcuno scambio di parole; cf. Lc 10,29-37).
La Chiesa impara dal mondo
Il prefetto ha riconosciuto, con franchezza, che né nella Bibbia, né nella storia cristiana la dignità umana è stata sempre adeguatamente salvaguardata. La Chiesa, sostiene, ha imparato dal mondo. O meglio, è avvenuto una specie di circolo ermeneutico: in primo luogo il Vangelo ha introdotto nella storia determinati convincimenti, mentre, in un secondo tempo, alcune convinzioni laiche sono state considerate dalla Chiesa apporti in grado di consentire una più fedele comprensione del Vangelo.
Le esemplificazioni fornite in proposito partono dal tema della schiavitù. In relazione alla Bibbia si cita un passo dell’Esodo: «“Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché l’ha comprato col suo denaro” (Es 21,20-21). Che cosa ha a che fare questo testo con l’immensa dignità di ogni persona umana? Niente!».
In riferimento alla storia della Chiesa si cita dapprima la bolla Dum diversa con cui, nel 1452, papa Niccolò V concesse di ridurre in schiavitù perpetua pagani e saraceni; a questo primo documento si contrappone la bolla Veritas ipsa (1537) con la quale Paolo III scomunicò coloro che sottoponevano gli altri alla schiavitù, «perché sono umani».
Sono elencati ulteriori casi. La libertà di coscienza, condannata nell’Ottocento da Gregorio XVI e dal Sillabo, è posta a fondamento della dichiarazione conciliare Dignitatis humanae. «Sono esempi, questi, che dimostrano come la comprensione della verità da parte della Chiesa si evolva nel corso del tempo».
Un ultimo passaggio esemplificativo è proposto al riguardo della pena capitale. La modifica del Catechismo della Chiesa cattolica avvenuta nel 2018 segna in proposito il culmine della riflessione della Chiesa sull’inviolabilità della dignità umana.1 Su questo argomento una citazione dell’enciclica Fratelli tutti (n. 269; Regno-doc. 17,2020,571) propone un ragionamento a minori ad maius: «Un fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l’inalienabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo. Perché se non lo nego al peggiore dei criminali, non lo negherò a nessuno».
Violenza interumana e valore infinito della persona
L’intreccio tra dignità umana, schiavitù e pena capitale trova una singolare corrispondenza in alcune discussioni rabbiniche relative alla legge del taglione. «Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido» (Es 21,24s; cf. Lv 24,19s; Dt 19,21). Il diritto ebraico rabbinico, prendendo le distanze dal senso letterale, intende il precetto in base al principio del risarcimento. In particolare un testo talmudico giunge a queste conclusioni: «Chi ferisce il suo prossimo, gli deve cinque cose: il risarcimento dei danni materiali, il prezzo della cura, l’indennizzo per la perdita del guadagno, il risarcimento dei danni morali, il risarcimento del disonore». Sorge però il problema di sapere in che modo si quantifichi il risarcimento dei danni materiali. La risposta si colloca nella sfera dell’ambiguità. Si dichiara, infatti, che se uno ha accecato un occhio o ha mozzato una mano o rotto un piede a qualcun’altro, si considera il ferito come uno schiavo che viene rivenduto al mercato, e si calcola quanto valeva prima e quanto vale ora. Da un lato, quindi, vi è un paragone che rende lo schiavo un metro di misura anche per la persona libera e ciò pone, di fatto, i due su un piano di parità; ma dall’altro si riconferma la legittimità della compravendita degli schiavi. Dalle due facce della questione si è tentati di concludere che il ricorso a una valutazione puramente monetaria del danno intacca, in un certo senso, la dignità dell’essere umano.
Le prassi assicurative contemporanee paiono non porsi simili problemi.
Sviluppando il discorso sull’indennizzo si giunge a toccare la questione della non riscattabilità della vita umana: «“Occhio per occhio” ha detto il Misericordioso! Io dico: davvero un occhio. Ciò non ti venga in mente: poiché è stato insegnato si potrebbe credere, uno ha accecato l’occhio di un altro, accechi questo il suo occhio [e così via per altri organi]. La Torah insegna: “Chi percuote a morte un uomo... Chi percuote a morte un capo di bestiame” (Lv 24,17-18). Come deve pagare il risarcimento dei danni uno che percuote a morte un capo di bestiame [cf. Lv 24,18], così deve pagare il risarcimento dei danni chi colpisce un uomo.2 Se vuoi dire qualcosa in contrario, vedi che la Torah dice: “Non accetterai prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di morte, perché dovrà essere messo a morte” (Nm 35,31). Per la vita di un omicida tu non puoi accettare prezzo di riscatto, ma certo tu puoi accettare prezzo di riscatto [persino] per gli organi principali, che non ricrescono» (Talmud babilonese, Bava Qamma, 82b).
Dall’obbligatorietà della pena di morte unicamente nel caso di omicidio si deduce che in tutti gli altri casi vada assunto il criterio del risarcimento. In altri termini, la compensazione monetaria, che ha in sé sempre qualcosa di potenzialmente lesivo della dignità della persona, deriva da un convincimento dell’esistenza di una realtà non risarcibile. Siamo di fronte a un principio che raggiunge, paradossalmente, la propria massima coerenza in discussioni risalenti a un’epoca nella quale la pena di morte risultava, di fatto, ineseguibile. Venuto meno il Sinedrio, i rabbi non avevano l’autorità di applicarla. La sua messa in opera infatti sarebbe ipso facto contraddittoria. La soppressione della vita di un omicida è anch’essa un omicidio. Non lo è però l’istanza di realtà non risarcibili.
Sia pure senza una precisa applicazione penale, si tratta di un problema antico che trova riscontro nelle parole pronunciate da Dio subito dopo la cessazione del diluvio: «Chi sparge il sangue dell’uomo, dall’uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l’uomo» (Gen 9,6). L’espressione «a immagine di Dio» era già stata proposta dalla Genesi (cf. 1,26s), ma solo ora viene introdotta come monito contro la violenza interumana basato su quanto, in termini moderni, potremmo chiamare la dignità della persona. Senza dimenticare che la proibizione è connessa però a una ricaduta di inquietante ambivalenza: «Il suo sangue sarà sparso».
Il raffronto tra la violenza interumana e il valore infinito della persona resta un nodo aggrovigliato, difficile da sciogliere in tutte le sue componenti, perché dotato, come un poliedro, di molte facce.
1 L’attuale formulazione del CCC 2267afferma che «la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona».
2 La stessa radice ebraica verbale nkh può significare sia semplicemente colpire, sia colpire a morte.