Un Messia «empio»
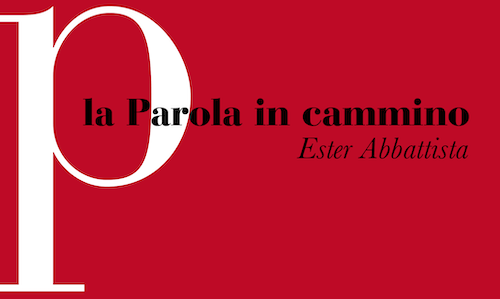
Domenica delle palme – Passione del Signore
Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56
In questo giorno – la Domenica delle palme – si fa memoria dell’ingresso regale di Gesù a Gerusalemme, a cavallo di un asino secondo la tradizione davidica, accompagnato dalla folla che acclama «Osanna al figlio di Davide». Si tratta di un vero e proprio corteo regale, e colui che siede a cavallo dell’asino è un discendente di Davide, il futuro re-Messia che tanto il popolo ha atteso e in cui ha sperato: un re-Messia che sia in grado di liberare il suo popolo, di porre fine alle sue sofferenze, di ristabilire il regno e la gloria di Davide, di realizzare così le promesse del Signore. Questa è la speranza e l’attesa di coloro che accompagnano Gesù lungo la discesa dal Monte degli ulivi, verso la città santa, Gerusalemme.
Tale commemorazione però avviene, liturgicamente, prima che si entri in chiesa. Una volta entrati, infatti, i fedeli sono chiamati ad ascoltare e fare memoria di un’altra storia, anch’essa vera, come la prima, ma di tutt’altro tenore: la passione e morte di Gesù.
Se ci si pensa il contrasto è forte, e se l’ascolto e la partecipazione sono attenti, si passa davvero da un momento di gioia e di esultanza a un momento di sconforto e di desolazione, proprio perché il tutto si conclude con la scena della sepoltura di Gesù.
Tutto sembra finito, le speranze deluse, le illusioni svanite e non si sa che cosa fare, cosa pensare e, soprattutto, cosa sperare.
È così che la liturgia ci prepara a questo intenso cammino di conversione che precede il giorno finale, quello luminoso della liberazione, il giorno della risurrezione.
È un cammino di conversione, proprio perché esige un cambiamento di sguardi, uno spostamento di prospettiva, un ribaltamento di giudizio: ciò che sembra finito, concluso, svanito per sempre è in realtà l’inizio di qualcosa che mai si poteva sperare, attendere e persino immaginare: la vittoria definitiva della morte. Non di una morte, ma di tutte le morti, dall’inizio della storia dell’umanità fino alla sua fine, in qualsiasi tempo questa avverrà.
Ma perché questa luce e certezza possa davvero abitare il nostro sguardo e animare il nostro cuore, bisogna passare prima in mezzo alle contraddizioni, a tutte le tensioni che l’umanità porta con sé, al desiderio di liberazione, di autodifesa, di risposta al male e alla violenza che muove i nostri cuori i nostri pensieri e le nostre mani verso l’«altro», verso il «nemico», verso quell’oppressore di turno che minaccia la nostra vita.
Nel racconto della passione secondo Luca, che si legge quest’anno, se ci si fa caso, vi sono proprio i segni di tale contraddizione.
A un certo punto Gesù rivolge questo discorso ai suoi: «“Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?”. Risposero: “Nulla”. Ed egli soggiunse: “Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: ‘E fu annoverato tra gli empi’. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento”». Sembra quasi che li stia invitando a prepararsi allo scontro, alla battaglia, ma proprio quando li vede pronti e armati – «Ed essi dissero: “Signore, ecco qui due spade”» –, ecco che «sembra» cambiare idea: «Ma egli disse: “Basta!”».
Così anche durante la scena dell’arresto sul Monte degli ulivi i discepoli, armati, cercano di difenderlo: «Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: “Signore, dobbiamo colpire con la spada?”. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio destro». Anche questa volta la reazione di Gesù è in contraddizione con l’ordine che egli stesso aveva dato ai suoi di comprare delle spade: «“Lasciate! Basta così!”. E, toccandogli l’orecchio, lo guarì».
Un’ulteriore contraddizione la si ha quando Gesù rivolgendosi a coloro che sono venuti a prenderlo, li rimprovera di essere venuti proprio con delle «spade»: «Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni», e la contraddizione sta proprio nel fatto che, come abbiamo visto, anche i suoi sono armati di spade.
Come spiegare queste contraddizioni? La chiave per comprenderle potrebbe essere proprio nelle parole che, come abbiamo letto, Gesù dice ai suoi discepoli per giustificare l’ordine di comprare delle spade: «Deve compiersi in me questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra gli empi”».
Difatti, la scelta che Pilato pone ai «capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo» è proprio questa: chiede loro di scegliere quale dei due «empi», Barabba o Gesù, liberare. Bisogna a questo punto chiarire che Barabba non era certo un brigante, ma un «rivoluzionario», che voleva liberare il popolo dalle violenze e dai soprusi dei romani con le armi, così come Luca stesso ci informa: «Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio». Inoltre, anche Barabba – lo dice il suo nome – era «figlio del padre»!
Alla fine Pilato libera uno e crocifigge l’altro, vincono la ragion di stato e la diplomazia, ma poco importa: ai suoi occhi erano ambedue «soggetti pericolosi».
E così dunque si compie la Scrittura: «E fu annoverato tra gli empi»; rimane però da capire chi sono davvero questi «empi». Ai nostri occhi non ci sarebbero dubbi a classificare come «empi» Pilato, i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo; ma Gesù non è con loro che viene annoverato, bensì con Barabba, con qualcuno che lotta, che è disposto a morire pur di liberare il suo popolo. E anche qui la contraddizione rimane e con essa l’interrogativo: con la spada o senza la spada? E di quale «libertà» si tratta? Abbiamo tutta una settimana per rifletterci.
