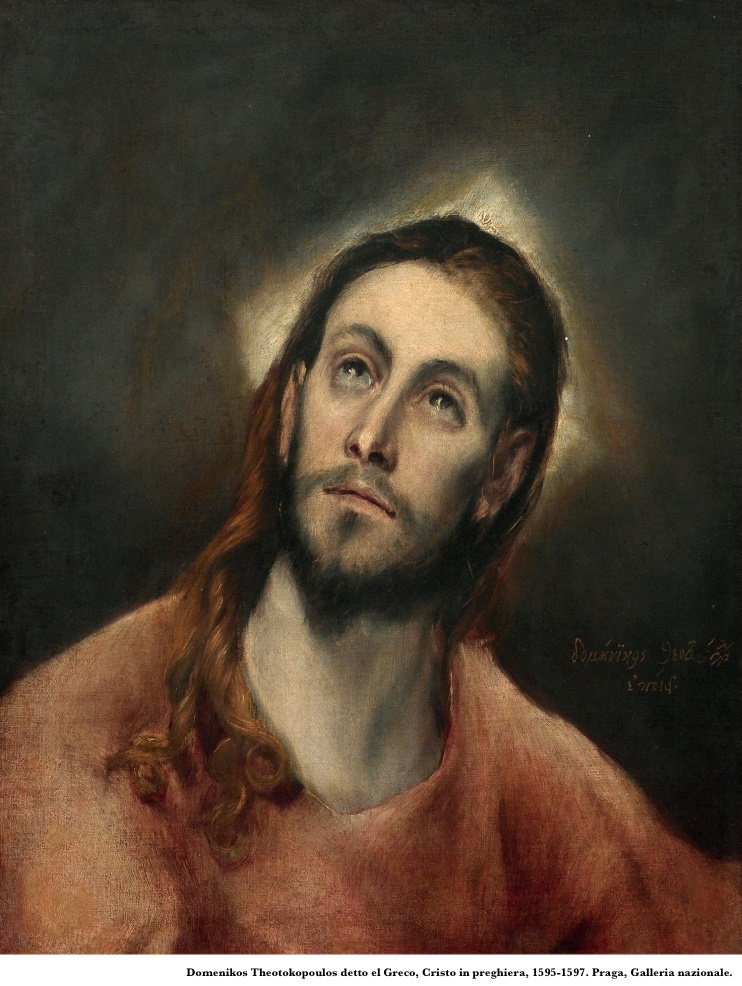«Insegnaci a pregare»
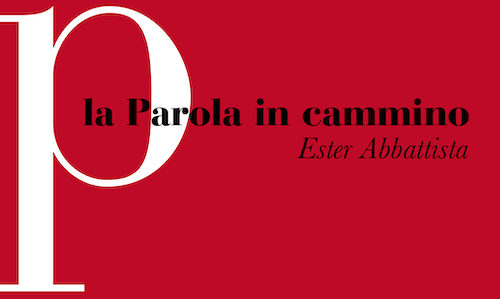
XVII domenica del tempo ordinario
Gen 18,20-32; Sal 137 (138); Col 2,12-14; Lc 11,1-13
Il Vangelo di questa domenica ci presenta la versione della preghiera del Padre nostro secondo Luca. Interessante è la domanda che introduce la risposta di Gesù e, conseguentemente, il testo della preghiera: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».
A prima vista tale domanda sembrerebbe indicare che i discepoli non sanno pregare o che non abbiano mai pregato fino a quel momento. La qual cosa ovviamente non è pensabile, dato che un ebreo del tempo recitava almeno due volte al giorno, al mattino e alla sera, il testo dello Shemà (Dt 6,4-8 «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore», ecc.), che viene riportato anche in Mc 12,29, e la preghiera detta ’Amidah, le Diciotto benedizioni.
Allora in che cosa consiste la domanda che i discepoli fanno a Gesù? Il primo indizio lo si trova proprio nella motivazione di questa domanda: «Come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Il riferimento a Giovanni e ai suoi discepoli indica che vi erano delle formule differenti del ’Amidah, che venivano utilizzate da diversi gruppi, anche come segno di appartenenza a un determinato rabbi o maestro.
Una riprova di ciò la troviamo nella Mishna: «Rabban Gamliel dice: “Un uomo dovrebbe pregare le Diciotto benedizioni ogni giorno”. R. Joshua dice: “La sostanza delle Diciotto”. R. Akiva dice: “Se la sua preghiera è fluente nella sua bocca egli deve pregare le Diciotto benedizioni, altrimenti solo la sostanza delle Diciotto”». Esistevano quindi delle formule «ridotte» del ’Amidah, e la richiesta dei discepoli a Gesù era proprio quella di fornire loro una versione «ristretta» di questa preghiera che li caratterizzasse come suoi seguaci.
Da quanto detto, anche se brevemente, si intuisce che la risposta data da Gesù, ovvero il Padre nostro che noi tutti conosciamo, non solo è una preghiera prettamente ebraica, ma è anche una preghiera che un ebreo, almeno del I secolo, non avrebbe avuto nessun problema a recitare.
Ogni affermazione/richiesta del Padre nostro, infatti, può essere rintracciata nella tradizione orante di Israele a partire proprio dalla prima frase: «Padre nostro». Espressione che ritroviamo in molti passi della Scrittura e, di riflesso, anche nella Mishna. Così anche «sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno e sia fatta la tua volontà» sono invocazioni che ritroviamo nella preghiera del Qaddish (santificazione del Nome) e/o nelle Diciotto benedizioni.
Alla dimensione verticale, che si concentra sul rapporto tra Dio e l’orante, segue poi la dimensione orizzontale, dove la preghiera volge lo sguardo sulla propria realtà esistenziale e relazionale con gli altri. La prima richiesta di questa seconda parte – «dacci oggi il nostro pane quotidiano» – ha sullo sfondo l’episodio della manna raccontato in Esodo 16, dove agli israeliti viene chiesto di fidarsi di Dio e di accogliere e riconoscere ciò che è necessario, secondo il proprio bisogno, ogni giorno come dono e segno della presenza del Signore nel loro cammino. Il desiderare di più o l’accaparrarsi oltre il proprio bisogno è non solo vano, ma «distruttivo»: «Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì» (Es 16,20).
La seconda richiesta – «perdona a noi i nostri peccati» – costituisce una variazione abbreviata della sesta delle Diciotto benedizioni di cui abbiamo parlato: «Perdonaci, Padre nostro, perché abbiamo peccato contro di te; cancella e togli le nostre iniquità davanti i tuoi occhi; infatti grande è la tua misericordia. Tu sia benedetto, Signore, che hai abbondantemente perdonato».
E la terza – «anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore» – viene vista come una conseguenza imprescindibile della seconda: Dio può perdonare i peccati commessi verso di lui, ma solo noi possiamo liberare dalla colpa coloro che commettono del male verso di noi, così come ad esempio si legge in un altro passo della Mishna: «Per le trasgressioni tra una persona e Dio, Yom Kippur [il giorno dell’espiazione in cui il popolo riceve il perdono di Dio] espia; tuttavia, per le trasgressioni tra una persona e un’altra, Yom Kippur non espia finché non placa l’altra persona» (MYoma 8,9).
Si giunge così all’ultima richiesta, quella che purtroppo oggi in italiano è stata «forzatamente» cambiata, ma che nella traduzione precedente (CEI 1974) del testo evangelico era più fedele all’originale: «e non ci indurre in tentazione». Anche in questo caso la tradizione ebraica può essere d’aiuto a comprenderne il senso, si legge infatti nel trattato Berakhot (60b): «Sia la tua volontà, o Signore mio Dio, che tu mi faccia riposare in pace e dammi la mia parte nella tua Torah, abituami alle mitzvot e non abituarmi alla trasgressione, non indurmi in errore, né in iniquità, né in tentazione, né in disgrazia. Possa la buona inclinazione avere il dominio su di me e possa l’inclinazione al male non avere il dominio su di me».
Alla fine di queste riflessioni, vorrei solo aggiungere un’ultima considerazione: forse molti cristiani non sanno che la preghiera del Padre nostro, che più di ogni preghiera ci identifica nella nostra fede, è una preghiera ebraica; sarebbe bello non solo saperlo, ma anche ricordarci che ogniqualvolta la recitiamo ci poniamo in sintonia e in comunione non solo con tutte le altre confessioni cristiane, ma anche con tutti i fedeli appartenenti al popolo ebraico e che Benedetto XVI ha definito «nostri padri nella fede» (L’Osservatore romano 17.1.2011).