Il Regno in un seme
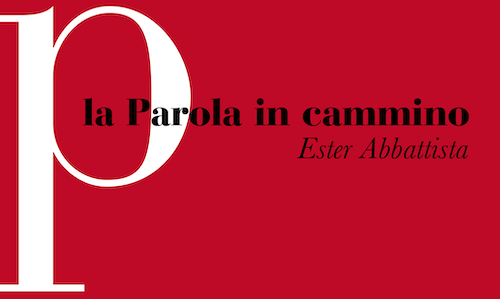
XI domenica del tempo ordinario
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
Il Vangelo di questa domenica ci presenta la parabola del seme di senape. Una parabola presente anche in Matteo e Luca. Nella variante di Marco gli uccelli fanno il nido non sui rami della pianta ma sotto la sua ombra.
Probabilmente le due versioni evangeliche fanno riferimento a due tipi di piante diverse, ambedue presenti in Israele: la brassica nigra (detta anche «senape nera»), che in condizioni ottimali può raggiungere anche più di due metri di altezza, e la salvadora persica, che invece produce un cespuglio la cui altezza non supera i 30 centimetri. In ogni caso si tratta di piante con un alto valore medicinale, dettaglio non trascurabile, come vedremo, per la comprensione della parabola.
Gesù vuole in qualche modo far comprendere ai suoi ascoltatori non solo che il regno di Dio è già presente, ma soprattutto come questo Regno si manifesta e si realizza: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Come già accennato prima, che in un «orto», o in un giardino che sia, si semini una pianta di senape è un’azione non solo abbastanza fattibile, ma anche non straordinaria o non fuori dalle possibilità di tutti. Il seminare poi una pianta di senape era anche un modo per avere a portata di mano la possibilità di usufruire delle sue benefiche qualità curative, stando a quanto lo stesso Plinio (filosofo naturalista vissuto nel primo secolo d.C.) afferma: «[la pianta di senape] è estremamente benefica per la salute, [utile] per i morsi di serpenti, scorpioni, mal di denti, indigestione, asma, epilessia, costipazione, edemi, apatia, tetano, ulcere da lebbra [ecc.]» (Plinio, Storia naturale 17.70).
Dopo la semina il resto lo fa la natura stessa, ovvero dal seme nasce una pianta che però, stando alla descrizione evangelica, diventa la più grande dell’orto e sotto la sua ombra gli uccelli possono farci il nido. Un piccolo seme, un’azione abbastanza comune e un risultato che produce benefici non solo riguardanti la pianta in sé, se Plinio ha ragione, ma che si estendono anche verso l’esterno: gli uccelli e il loro nido.
Questa immagine così «casalinga», semplice e quasi «ordinaria» è la descrizione evangelica del regno di Dio. Il paradosso e anche lo scarto stanno proprio in questa immagine e nella portata del messaggio in essa racchiuso. Per comprendere tale messaggio, infatti, bisogna fare un cambiamento di visuale, quello che nel greco evangelico viene definito una «metanoia», un cambiamento di mentalità, di giudizio, di comprensione.
Quando si parla di «regno» si pensa a qualcosa di grande, di imponente, di forte, la cui presenza o ascesa appare irresistibile e incontenibile; di fatto è questa l’esperienza storica che il popolo ebraico ha sperimentato lungo i secoli di permanenza nella terra di Canaan: l’ascesa dei vari imperi – assiro, babilonese, persiano, ellenistico, romano – rimane nell’immaginario collettivo come una forza immane che sovrasta inarrestabile, imponendosi con la propria grandezza e potere.
Anche oggi l’idea di regno, di impero non è tanto dissimile, e anche se le diverse tipologie di «imperi» possono essere cambiate, non sono cambiati gli effetti e le ricadute a largo raggio del loro potere. Paragonare il regno di Dio, rispetto ai «regni» di ieri e di oggi, a un cespuglio di senape è davvero a dir poco spiazzante, ma allo stesso tempo carico di una speranza difficile – permettetemi l’espressione per rimanere nell’ambito botanico – da sradicare. È proprio questa, infatti, la forza racchiusa nel regno di Dio: da una parte collaborare alla sua crescita è alla portata di tutti, è come seminare un piccolo granello di senape e attendere che il frutto di quel seme diventi «ombra» e rifugio, consolazione e vita per altri; dall’altra, il segreto sta proprio nella capacità di sperare, cioè di attendere, che Dio faccia il resto.
Nella lingua ebraica infatti la radice che dà vita al verbo «sperare» è la stessa che è alla base del verbo «attendere». La speranza, di fatto, ha dentro di sé l’attesa di vedere compiersi ciò che si spera, ma allo stesso tempo ogni attesa è di per sé carica di speranza. È questo lo sguardo che ci viene chiesto di avere per essere «seminatori» del Regno, un Regno che non ha bisogno di poteri forti e imperialistici, ma semplicemente di piccole e semplici azioni come quella di voler piantare un piccolo «granello di senape» nel pezzo di creazione che ci è stato affidato, in quella piccola porzione di creato che inabitiamo insieme agli altri.
