Battesimo: un itinerario
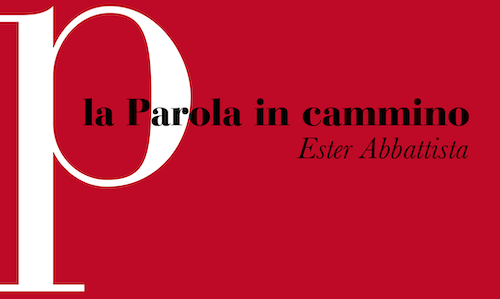
Battesimo del Signore
Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,1-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
Diversamente da Marco e Matteo, Luca descrive la discesa dello Spirito su Gesù in forma di colomba, non in contemporanea al battesimo ricevuto da Giovanni, ma subito dopo: «Mentre (…) Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba». In questo modo l’accento sulla discesa dello Spirito viene posto non tanto in collegamento al fatto che Gesù sia stato battezzato da Giovanni, ma che, dopo tale azione, egli se ne stava in preghiera. Perché questa differenza? Cosa cambia?
Certamente il messaggio centrale è comune a tutti i tre evangelisti, ma anche piccole sfumature, come questa, possono suggerire ulteriori riflessioni. Ad esempio il fatto di separare l’azione del battesimo da quella della discesa dello Spirito può farci riflettere sia sull’uno che sull’altro aspetto.
Gesù si mette in fila con gli altri peccatori, chiede di ricevere il medesimo battesimo: la sua è un’azione di solidarietà, di immersione nella realtà del suo popolo, egli è uno di loro.
Ma ricevere il battesimo non basta, ciò che permetterà a Gesù di compiere la volontà del Padre sarà la sua relazione con lui, il dare tempo e spazio alla preghiera, ovvero all’ascolto. È interessante, infatti, che è tale preghiera che permette non solo la discesa dello Spirito, ma anche l’ascolto di «una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”». In tali parole c’è racchiusa l’identità di Gesù: egli è suo figlio; la qualità della relazione con il Padre: egli è l’amato; la sua missione: «In te ho posto il mio compiacimento».
Per quest’ultima indicazione, forse è bene ricordare che alle orecchie di un ebreo l’espressione «in te ho posto il mio compiacimento» è un richiamo esplicito a un passo del profeta Isaia: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni» (Is 42,1).
In questa scena, così descritta, ci sono tre momenti o tappe che possono aiutarci a riflettere sul cammino di fede di un credente. La prima tappa è il desiderio di far parte di una realtà di cui si condividono i valori, le scelte; per esempio di un impegno sul piano sociale, di essere dalla parte dei poveri, degli esclusi, di far causa comune con chi è nel bisogno. È ciò che oggi chiamiamo «volontariato» e che, ovviamente, può declinarsi a vari livelli e con varie sfumature. A volte ci si accosta a una realtà ecclesiale, a una comunità credente perché attratti dal desiderio di «fare» qualcosa, di sentirsi utili. Ma questa è solo una tappa che, se non viene alimentata da altro, può finire per diventare sterile e il desiderio iniziale può naufragare in aridità di vario tipo.
La seconda tappa è la preghiera, ovvero il desiderio di vivere una relazione personale con il Signore, il desiderio di conoscere e ascoltare la sua Parola, di crescere in una familiarità con lui attraverso la sua «frequentazione». La preghiera non è per prima cosa dialogo, che spesso si trasforma in un monologo interiore, e neanche la ripetizione di formule o frasi, ma è principalmente ascolto, un ascolto attento, raccolto, intenso. È desiderio, ricerca, attesa di quella relazione che lo Spirito suscita e anima attraverso l’apertura del cuore e l’accoglienza del dono della rivelazione della Parola del Padre.
Ed è proprio il dono dello Spirito, la terza tappa, ciò che permette di comprendere quella Parola, di discernere il cammino da compiere per realizzare il senso della propria esistenza secondo la volontà del Padre che, nel caso di Gesù, è proprio «in te ho posto il mio compiacimento» (con tutto ciò che segue nel rimando al testo di Isaia).
Inoltre è bene tenere presente che questi tre momenti non avverranno solo una volta, ma caratterizzeranno tutta la vita di Gesù, il suo cammino, le sue scelte, la sua missione fino a quello che sarà il momento finale dove, di nuovo, «una voce» confermerà il suo itinerario messianico: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (Lc 9,35); e sarà proprio questa conferma che spingerà Gesù verso il compimento del suo ministero messianico a Gerusalemme.
La stessa cosa avviene per il sacramento del battesimo che, ricevuto da bambini o da adulti, non è di per sé sufficiente a fare di una persona un credente. La volontà, il desiderio di essere parte di una comunità di credenti, di riconoscersi all’interno di una storia di salvezza, di aderire con la propria vita al progetto di senso che Dio ha pensato per ciascuno di noi, implica un itinerario, un cammino, in cui il «fare» va costantemente alimentato dalla preghiera, dalla cura della nostra relazione con il Signore, dal dono dello Spirito che va sempre accolto – e mai dato per scontato – e dall’ascolto attento e costante di quella «voce» che è la sua Parola.
-tjvv3).jpg)