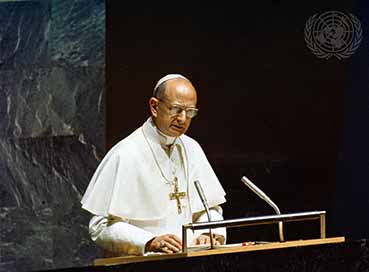La teologia del popolo: popolo e democrazia - Speciale Francesco
Quella di «papa populista» è una critica che è stata rivolta a Francesco, soprattutto a partire da un insistente richiamo al popolo, in primo luogo sotto il profilo ecclesiologico ma con inevitabili risvolti politici, e poi anche a partire dalle sue radici latinoamericane e più nello specifico argentine. Ma su questo punto nella riflessione di papa Bergoglio si registra un progressivo approfondimento, che ha portato Francesco a superare una concezione «neutra» del termine, fino a identificare chiaramente il populismo come una strumentalizzazione della volontà popolare a scopi di potere personale.
La contrapposizione tra «popolo» e «populismo» costituisce l’esito di un percorso che si snoda nel corso dei dodici anni in cui Bergoglio ha svolto il suo servizio petrino. Ricostruirne, sia pure per sommi capi, le tappe consente di cogliere una dinamica interna al pontificato di Francesco ed eliminare un’ombra che pesa nell’interpretazione del suo esercizio del ministero papale.

Nell’insegnamento che papa Francesco ha ora consegnato alla storia ricorre con insistenza il richiamo al «popolo». In primo luogo sotto il profilo ecclesiologico. Il pontefice infatti riprende dalla costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, promulgata dal concilio Vaticano II (1964), la concezione della comunità ecclesiale come «popolo di Dio». La sviluppa poi in diverse direzioni: la promozione della sinodalità come partecipazione di tutti i battezzati alle decisioni pastorali; la denuncia del clericalismo, in quanto piaga che rovescia il servizio ai fedeli in potere; il coinvolgimento dei laici, a partire dalle donne, al governo dell’istituzione e così via.
Non a caso la «teologia del popolo» ha costituito una delle radici culturali su cui sono maturate le scelte compiute da Bergoglio prima e dopo l’accesso al soglio di Pietro. Rappresenta la versione argentina della teologia della liberazione, i cui esponenti, come Lucio Gera e Juan Carlos Scannone, pur rifiutando gli strumenti marxisti di analisi della società, avevano ricavato dal Vaticano II, come criterio per orientare la presenza della Chiesa nel mondo attuale, il nesso tra annuncio evangelico ed emancipazione delle masse popolari dalle condizioni di povertà materiale e spirituale in cui erano confinate dai vigenti assetti di potere.
Il richiamo di Francesco al «popolo» ha quindi un inevitabile risvolto politico. In queste brevi note mi limito a prendere in considerazione questo solo aspetto. Del resto appare tutt’altro che secondario. Lo testimonia il discorso tenuto dal pontefice a Trieste nel luglio 2024 in un’importante occasione: la celebrazione della cinquantesima Settimana sociale dei cattolici italiani.
Distorsione democratica
Il papa, dopo aver premesso che la parola «popolo» è inscindibilmente legata al concetto di democrazia (appunto governo del popolo), osserva che «purtroppo» il ricorso al popolo è spesso servito per abbattere gli ordinamenti democratici. «Ciò nonostante – asserisce – per affermare che la società è di più della mera somma degli individui, è necessario il termine “popolo”». A suo avviso infatti solo se il cittadino, pur senza perdere la sua individualità, si fa popolo, nasce quel progetto di città futura che fa vivere la democrazia nel difficile fluire della storia.
Insomma nella visione di Bergoglio una democrazia regge nella misura in cui l’impegno personale si coniuga con quello comunitario nell’elaborazione di un disegno per il futuro. Francesco ha cura di precisare che questa sua valorizzazione del popolo «non è populismo», perché «altra cosa» è il popolo dai populismi che percorrono il mondo contemporaneo. Verso la conclusione del suo governo, nel sottolineare che il richiamo al popolo è funzionale alla promozione della democrazia, il pontefice ha quindi voluto sottolineare che l’uso corretto di questa categoria è insidiato dalla distorsione che ne compie il populismo.
La contrapposizione tra «popolo» e «populismo» costituisce l’esito di un percorso che si snoda nel corso dei dodici anni in cui Bergoglio ha svolto il suo servizio petrino. Conviene qui ricostruirne, sia pure per sommi capi, le tappe. In tal modo, oltre a cogliere una dinamica interna al pontificato, si può eliminare un’ombra che pesa nell’interpretazione del suo esercizio del ministero papale.
Un papa «populista»?
In effetti in ambito cattolico, come al di fuori di esso, ha goduto di larga fortuna una stigmatizzazione della figura del pontefice come «populista». Anche se talora presentata come correzione di una (effettiva) sovraesposizione mediatica, in cui la celebrazione del personaggio ha preso il posto dell’informazione sui contenuti del suo governo, quella connotazione ha in realtà mirato a un obiettivo preciso: sminuire la portata innovativa del suo magistero, al punto che, in qualche caso, si è giunti a inquadrarlo sotto l’etichetta della «reazione».
L’operazione è stata per lo più condotta sulla base della costatazione che, prima di diventare vescovo di Roma, Bergoglio aveva coltivato rapporti con diversi esponenti di quella cultura politica che, nell’Argentina peronista, aveva saldato cattolicesimo e populismo nell’esaltazione della «nazione cattolica». Ci si può ovviamente chiedere se un pastore di anime, in un generale contesto ecclesiale in cui Roma guardava con favore allo sviluppo delle tendenze nazional-populiste in America Latina, avrebbe potuto fare altrimenti. In ogni caso non ha alcun fondamento la proiezione di quel passato nella lettura dei successivi documenti papali.
Avviene infatti sulla base dell’individuazione di estrinseche analogie di concetti politici e politico-religiosi. Ora, al di là del fatto che tale sovrapposizione risulta compiuta senza puntuali riscontri filologici che la rendano criticamente fondata, un dato è incontrovertibile: quali che fossero le sue posizioni precedenti, Francesco da papa ha esplicitamente affrontato la questione del populismo e del suo rapporto con la categoria di popolo. Dalla considerazione di questo materiale documentario non si può prescindere per un giudizio obiettivo in materia.
Senza dubbio al bagaglio culturale dell’arcivescovo di Buenos Aires, che nel 2013 arriva al soglio di Pietro, non appartiene un’approfondita conoscenza delle opere storiografiche relative alle vicende dei movimenti che tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si sono autodefiniti «populisti». Così come è difficile trovarvi tracce delle elaborazioni politologiche che dallo scorcio del Novecento, soprattutto in relazione ai mutamenti messi in moto dai processi di globalizzazione, hanno visto nella costruzione politico-culturale di una contrapposizione manichea tra élite e popolo il canale attraverso cui nelle democrazie rappresentative nuovi ceti dirigenti arrivavano a conquistare il potere.
In queste carenze sta probabilmente la ragione dell’inziale ambiguità papale a proposito del «populismo», che traspare fin dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium, pubblicata il 24 novembre 2013, in cui il pontefice enuncia il suo programma di governo. Qui infatti, dopo aver sostenuto che i responsabili politici non possono affidarsi alla mano invisibile del mercato, ma devono compiere concreti interventi volti a una migliore distribuzione delle entrate pubbliche, egli afferma che non intende così proporre un «populismo irresponsabile» (n. 205), bensì sollecitare misure che evitino l’incremento di povertà ed esclusione. Si ha insomma l’impressione che, ai suoi esordi, Francesco ritenga che il termine possa anche avere un’accezione positiva.
Lo conferma l’intervista rilasciata nel 2015 al direttore de La Civiltà cattolica, Antonio Spadaro, che fin dall’inizio del pontificato è apparso come uno degli interlocutori privilegiati dal papa gesuita per rendere noti i suoi orientamenti. Mostrandosi in qualche modo infastidito per l’eccesso di attenzione mediatica alla questione – i giornalisti francesi gli avevano posto insistenti domande in proposito durante il viaggio di ritorno dalla Terra santa nel maggio 2014 –, osserva che il rigetto del populismo è frutto di un equivoco. Infatti la parola, in quanto indica una conformazione alla volontà del popolo, può acquisire un significato politico del tutto positivo. Se ne può quindi dedurre che agli occhi del papa, a queste date, si può distinguere tra un populismo «buono» e uno «cattivo».
Correzione di rotta
Intanto comincia a profilarsi una campagna volta a denigrare Francesco come populista. Al di là dei settori tradizionalisti – la cui furibonda ossessione ideologica li spinge ad appropriarsi di ogni critica a un pontificato giudicato, con sconfortante semplicismo, «progressista» –, sono anche degli studiosi ad avviare il processo di interpretazione di Francesco sulla base di interventi e gesti del Bergoglio dell’epoca peronista. Non sappiamo se il pontefice abbia deciso di rispondere a questi suoi critici, ma è un dato di fatto che a partire dal 2017 la sua trattazione del tema risulta più frequente e più esplicita. Ed è dunque su questi passi, da cui emerge l’autoconsapevolezza di Francesco in materia, che si può condurre un’adeguata indagine conoscitiva sulle sue concezioni.
Dalle interviste e dalle conferenze stampa che si distribuiscono nel corso di quell’anno, si ricava in primo luogo un atteggiamento di cautela. In alcuni casi il papa ricorda che, per rispondere in maniera appropriata alle domande su movimenti populisti in atto, come accade in Francia, non ha sufficienti informazioni; in altri casi osserva che la questione ha una complessità tale che non è possibile formulare in maniera sintetica una valutazione sufficientemente fondata; in altri ancora riconosce di poter avanzare solo un giudizio approssimativo per la mancanza della strumentazione culturale di uno scienziato della politica. Ma altrove sta l’aspetto più interessante e importante delle sue considerazioni.
Afferma infatti che ha dovuto «reimparare» a usare il termine, perché in America Latina ha un significato diverso da quello corrente in Europa. Il papa confessa che inizialmente non capiva molto quando gli parlavano di populismo, dal momento che per la sua cultura latinoamericana la categoria indicava semplicemente il riconoscimento del protagonismo dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione delle forme organizzative della comunità politica.
Poi, alla luce della storia del vecchio continente, ha cominciato a comprendere che in Europa il concetto ha assunto un contenuto ben diverso. Qui è infatti la vicenda del nazismo a determinarne il significato, dal momento che ne rivela in maniera esemplare il meccanismo di produzione. Il papa lo descrive puntualmente.
Un leader carismatico, approfittando di una situazione di difficoltà economica e sociale del popolo, ne ottiene il consenso elettorale con la promessa di risolvere tutti i suoi problemi. In realtà ha l’obiettivo di imporre, ricorrendo alla violenza, il proprio potere personale. Conseguitolo, procede, sotto la veste dell’affermazione di una presunta primazia internazionale di quel popolo, cui ha intanto tolto la possibilità di un’effettiva rappresentanza di interessi e aspirazioni, alla rottura traumatica dei rapporti di solidarietà che legano tra di loro i diversi popoli della terra.
Occorre sottolineare che in questa fase del discorso pubblico di Bergoglio sul populismo emerge un tratto del tutto inusuale nella millenaria storia dello svolgimento della funzione papale: l’aperta ammissione di una correzione di rotta in seguito al riconoscimento di un’insufficienza culturale. Ma non mi soffermo su questo aspetto, che ha, in altri temi dell’insegnamento papale, espressioni ancora più rilevanti. Conviene invece osservare che, a partire da questa data, il riferimento del papa al populismo è costantemente connotato con un segno negativo.
Vi sono rarissime eccezioni. Oltre all’unica occorrenza di un possibile «populismo cristiano» in occasione della messa in ricordo di don Pino Puglisi nel settembre 2018, in un altro caso Francesco censura l’utilizzazione del termine in chiave meramente polemica come una sorta di insulto diretto a colpire l’avversario politico nel dibattito pubblico. Per il resto il populismo è presentato regolarmente come una strumentalizzazione della volontà popolare a scopi di potere personale.
Migrazioni e globalizzazione
Al di là del nazismo – il caso storico da cui è partito il ripensamento papale – Francesco ricorda che le sue manifestazioni si ammantano delle più varie vesti ideologiche. Ne constata la presenza anche all’interno dei regimi democratici, quando per la conquista o la permanenza al potere i responsabili della cosa pubblica giungono, come scrive nell’enciclica Fratelli tutti (ottobre 2020), a fomentare «le inclinazioni più basse ed egoistiche della popolazione» (n. 159). Non sembra avventato ritenere che alcune scelte di politica internazionale della Santa Sede abbiano qui la loro radice.
Proprio in quest’ultimo documento, chiarito l’atteggiamento verso il populismo, il pontefice giunge a esplicitare in maniera più articolata quel rapporto tra popolo e democrazia che è al centro delle sue considerazioni sulla questione. Nella sua concezione il popolo – la cui analisi storico-politica affida agli strumenti logici delle scienze umane – costituisce anche una categoria mitica, in quanto esprime quel complesso inestricabile di legami sociali e culturali in cui si manifesta l’identità di una comunità politica.
Per questa ragione Francesco stabilisce un nesso tra l’appartenenza a un popolo e la capacità di elaborare quel «sogno collettivo» che è la condizione per un progetto a lungo termine di convivenza. Occorre qui rilevare che il conseguimento di un progetto condiviso è considerato come esito di un dialogo tra le diverse componenti interne a un popolo, che non esclude lo scontro tra di esse, ma lo ordina al raggiungimento del bene comune. In tal modo viene accantonata dal papa quella rappresentazione olistica del popolo in cui si è soliti identificare un tratto fondamentale del populismo.
In sintesi si può dire che, secondo Francesco, il riferimento al popolo consente a un ordinamento democratico, basato sul rispetto delle sfere di autonomia dei singoli, che la tutela dei diritti individuali non sfoci nella dissoluzione del vincolo comunitario, in quanto permette di alimentare le ragioni mitiche della coesione sociale. Non si tratta di limitare le rivendicazioni delle persone perché, in questa prospettiva, la loro attiva partecipazione al progetto condiviso, lungi dal mutilarne la dignità, ne comporta una sempre più piena valorizzazione.
Nel suo richiamo al popolo il pontefice sottolinea due ulteriori aspetti che è opportuno ricordare. Sul piano interno, con evidente riferimento alla questione migratoria, egli osserva che la categoria di popolo consente un positivo approccio dinamico alla questione: la sua proiezione verso il futuro lo rende «costantemente aperto a nuove sintesi, assumendo in sé ciò che è diverso» (n. 160). Senza negare la sua identità, il popolo è disponibile «a essere allargato, arricchito da altri, e in tal modo può evolversi».
A livello planetario, con uno sguardo rivolto alla globalizzazione, Francesco afferma poi che la categoria di popolo permette di uscire dalle chiusure di una pretesa autosufficienza. Radicati nella loro identità e consapevoli della loro irriducibile specificità, tutti i popoli si riconoscono componenti parziali di una composita umanità che li supera. Ne deriva la comprensione che il loro stesso sviluppo non può che passare attraverso l’esercizio di un dialogo fraterno.
Nel provvisorio bilancio, che si può tracciare al termine del pontificato, il discorso di Francesco sul popolo lascia, oltre alla costatazione della ricchezza e della profondità di un’argomentazione originale, qualche problema aperto. In particolare restano da specificare i rapporti di questa categoria con altre categorie centrali della scienza politica, come nazione e Stato.
Tuttavia si può immaginare che, anche in questo caso, il papa si sia proposto di avviare processi per immettere nella storia presente una comunità ecclesiale spesso cristallizzata nella nostalgia di una tramontata cristianità. Nell’età del trionfo dei populismi che minacciano le democrazie liberali, il richiamo al nesso tra popolo e democrazia ha infatti fornito ai credenti (ma anche ai non credenti) una strumentazione significativa per una più lucida intelligenza della realtà politica.
Daniele Menozzi