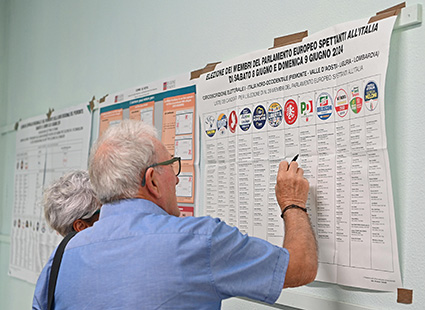Italia - Politica: cerco un centro…
I cattolici, gli italiani e le leadership politiche
Si torna a parlare di «centro». Se ne parla per lo più come di un’area dello spazio politico popolata da elettori cattolici in cerca in quanto cattolici di una migliore rappresentanza politica, fuori dalle e dentro alle coalizioni esistenti.
Si torna a parlare di «centro». Se ne parla per lo più come di un’area dello spazio politico popolata da elettori cattolici in cerca in quanto cattolici di una migliore rappresentanza politica, fuori dalle e dentro alle coalizioni esistenti.
Ai tempi della Democrazia cristiana (DC) la probabilità che un elettore che si recava ogni domenica a messa si collocasse al centro della scala sinistra-destra era indubbiamente elevata. Ma era più di 30 anni fa e prima di alcuni terremoti politici, incluso quello che ha travolto la DC stessa.
Il dibattito italiano sembra invece lasciare pensare che nonostante tutto poco o nulla sia cambiato al riguardo. A tal punto che, se ci s’interroga sui limiti dell’offerta politica attuale (domanda che ha un suo fondamento), si assume che l’insoddisfazione debba essere più alta tra i cattolici in quanto elettori di centro e che in questa area ci siano più cattolici che altrove.
Non abbiamo la possibilità di occuparci qui della prima assunzione. Ma quanto alla seconda non c’è alcuna evidenza che nell’ultimo quarto di secolo i cattolici abbiano manifestato o manifestino una propensione centrista prevalente rispetto ad altre appartenenze ideologiche.
La figura 1 mostra dove si collocano sulla scala sinistra-destra gli italiani considerati in generale e in base alla loro frequenza alla messa. I dati sono ricavati dall’European Social Survey (ESS), un progetto europeo che dal 2003 analizza l’opinione pubblica di vari paesi europei, tra i quali il nostro che tuttavia ha partecipato solo a 6 delle 11 rilevazioni attuate. L’ESS rappresenta il punto di riferimento europeo delle indagini demoscopiche comparate per la qualità dei suoi campioni, il disegno di ricerca, l’accuratezza con la quale le interviste vengono fatte e il tasso di risposta, il che consente di generalizzare con qualche fiducia le stime del campione alla popolazione di riferimento.
Il quadro illustrato dalla figura è molto chiaro. Dal 2003 al 2024 chi va a messa una volta o più volte alla settimana non manifesta una propensione maggiore a collocarsi al centro della scala sinistra-destra rispetto agli italiani in generale e a coloro che non vanno mai o poco a messa. Lo scarto tra i praticanti settimanali e gli altri due gruppi che s’intravvede nei primi due anni è modesto e scompare del tutto negli anni successivi.
La figura 1 suggerisce anche un’altra cosa. Lo spostamento a destra dei praticanti settimanali, visibile nel divaricarsi della linea che li rappresenta rispetto alle linee relative agli altri due gruppi, in coincidenza proprio delle posizioni della scala superiori a 5. Tradotto in numeri, la collocazione media dei praticanti settimanali sulla scala sinistra-destra sale in un quarto di secolo di mezzo punto. Era 5,0 nel 2003 e diventa 5,5 nell’ultima rilevazione. Va subito aggiunto che nel corso del periodo lo spostamento a destra si verifica pure tra chi non va a messa, anche se è di entità minore (tre decimi di punto a fronte di mezzo punto).
C’è tuttavia una cosa importante che la figura 1 non mostra. Come sappiamo da altre indagini, i cattolici sono oggi in minoranza tra gli italiani più di quanto lo erano un quarto di secolo fa (cf. «Gli italiani e la religione: lento, procede il declino»; Regno-att. 15, 2023,595). Questo fa sì che pure tra chi si colloca al centro della scala sinistra-destra i frequentanti settimanali siano oggi più minoranza di ieri. Erano il 30% nel 2003 e nel 2013. Dal 2017 in poi oscillano tra il 22% e il 25%.
I cattolici sono come gli altri
In tutto il periodo la percentuale di cattolici che si collocano al centro non si discosta mai da quella presente nella popolazione in generale. In altre parole tra chi si colloca al centro i frequentanti non sono mai sovra-rappresentati rispetto alla popolazione in generale: un altro indizio che conferma che la consuetudine di recarsi ogni domenica a messa non pare all’origine della scelta di collocarsi al centro.
Probabilmente questa scelta dipende da altri fattori, tanto per i cattolici quanto per gli altri. In effetti, chi si colloca al centro pare essere meno interessato alla politica degli italiani che si collocano invece a destra o a sinistra del centro. Il che vorrebbe dire che tale scelta ha una motivazione simile a quella che porta un certo numero di intervistati a respingere in toto la rappresentazione dello spazio politico basata sull’alternativa sinistra-destra.
Insomma, il nesso di cui si torna spesso a parlare tra collocarsi al centro e manifestare orientamenti cattolici è solo immaginario. I cattolici non si distinguono dagli italiani quanto a orientamenti ideologici. Si sono solo spostati a destra in misura un po’ più grande degli altri.
A questo punto ci si potrebbe chiedere se parlare di centro sia solo uno spreco di tempo. Non è affatto così. Ma occorre innanzitutto chiarire in che senso si parla di «centro». Nel dibattito pubblico si parla di «centro» intendendo, come sappiamo, l’area scelta da elettori che accettano la rappresentazione dello spazio politico incardinata sull’alternativa sinistra vs destra, ma che, in virtù di una loro identità pre-politica, si rifiutano di dare una qualche direzionalità alla propria posizione ideologica, né verso sinistra né verso destra.
Tuttavia una definizione del genere è in fondo anacronistica. Era una rappresentazione adeguata dello spazio politico in cui dominava la DC come partito di cattolici che si definiva anche di centro.
Oggi ha ancora senso parlare di «centro» se con questa espressione intendiamo l’insieme di elettori che esprimono opinioni su un tema che risultano essere in un dato momento centrali nella distribuzione complessiva, e per questa ragione potenzialmente maggioritarie tra gli elettori. Un esempio al riguardo è fornito dalla tabella 1, che mostra le opinioni degli italiani sul tema sempre caldo dell’accesso degli immigrati extra-europei in Italia.
Come si vede, a eccezione del 2017, l’opinione prevalente, nel senso di più diffusa, è sempre a favore di una politica di porte socchiuse, si direbbe, che lascino passare solo «alcuni». L’orientamento maggioritario tra gli italiani sta a cavallo delle opzioni «alcuni» e «pochi». Infatti la somma delle percentuali di coloro che scelgono queste due opzioni oscilla tra 2/3 e quasi 3/4 degli italiani.
La preferenza della maggioranza degli italiani potrebbe allora venire collocata tra i valori 2 e 3 attribuiti alle due opzioni. Sembra suggerirlo anche la media che in tutti gli anni è sempre superiore a 2 e in alcuni anni, come il 2013, il 2017 e il 2019 è superiore al 2 di 6 o di 9 decimi di punto.
Il centro è un punto variabile
Potremmo allora dire che la maggior parte degli italiani è a favore di una politica selettiva, e in questo senso le loro preferenze definiscono il centro dell’opinione pubblica su quel tema e in quegli anni, anche se si dividono su quanto debba essere selettiva. Possiamo forse qualificare più precisamente la centralità di questo segmento di opinioni, considerando una misura di tendenza centrale diversa dalla media. Lo si è fatto nelle analisi i cui risultati sono illustrati nella figura 2.
La figura mostra dove si collocano le opinioni degli italiani sui tre temi in una scala da 0 a 10, dove 0 indica la posizione più favorevole agli immigrati e 10 quella più ostile dal 2003 al 2023-2024.
Il trattino verticale all’interno dei rettangoli indica la posizione che divide la distribuzione in due parti eguali, cioè la mediana. A destra e a sinistra di quella posizione sta il 50% degli intervistati. Il valore della mediana più frequente nei vari anni e per i tre temi è 5. È quello il punto centrale della distribuzione delle opinioni, anche se è un punto mobile.
Infatti nel 2013 la mediana relativa alle opinioni sul contributo degli immigrati alla cultura italiana scende a 4. Questo significa che in quell’anno il 50% degli intervistati esprimeva opinioni più orientate verso una visione positiva della presenza degli immigrati nel nostro paese. Nel 2017 e nel 2019, invece, la mediana delle opinioni sull’impatto degli immigrati sulla vita quotidiana degli italiani sale a 6, il che indica che, su questo tema e in quei due anni di mobilitazione anti-immigrati particolarmente forte, il 50% degli italiani esprimeva opinioni più prossime a una visione negativa sulla presenza degli immigrati, cioè al valore 10.
I rettangoli indicano invece l’intervallo della dispersione delle opinioni attorno alla mediana tra due punti, il primo 25% (primo quartile) e il terzo 25% (terzo quartile) della distribuzione complessiva. In questo intervallo si colloca quindi il 50% di tutte le opinioni degli intervistati. Le linee a sinistra e a destra dei rettangoli indicano invece i restanti casi della distribuzione.
Poiché i rettangoli indicano la dispersione delle opinioni attorno alla mediana, è ovvio che si spostino nello spazio se si sposta la mediana, come si vede subito nella figura 2. Questo allora vuole dire che nello spazio definito dalla distribuzione delle opinioni esistono non solo punti centrali mobili ma anche segmenti d’opinione pubblica centrali mobili, a seconda del tema in questione.
Prendiamo un altro tema ad esempio: il riconoscimento o meno del diritto delle persone omosessuali di scegliere di vivere come desiderano. Nel periodo considerato la stragrande maggioranza degli italiani riconosce loro questo diritto e quindi su questo tema specifico il segmento centrale e maggioritario dell’opinione pubblica è molto prossimo al polo libertario. Viceversa sono in minoranza, anche se in crescita, coloro che riconoscono alle coppie gay anche il diritto di adottare un bambino. Il che vuole dire che in questo caso il segmento centrale e maggioritario è prossimo al polo conservatore.
Un altro esempio: sul tema relativo al processo di costruzione europea la distribuzione della maggioranza delle preferenze tra il 2003 e il 2024 è rimasta tra una posizione moderatamente ostile e una moderatamente favorevole, come nel caso delle opinioni sull’immigrazione illustrato dalla figura 2.
Motivare: il caso delle opinioni sull’Ucraina
Tutto ciò suggerisce una prima considerazione. Il «centro», inteso come il segmento di opinioni tendenzialmente maggioritarie, non è predeterminato come ci si immagina lo sia l’area centrale della scala sinistra-destra, tanto più se si è convinti che i confini del centro coincidano con i confini di un’identità connotata in senso religioso.
La seconda considerazione è che il «centro», inteso come segmento che racchiude potenzialmente la maggioranza di opinioni su un tema, non è omogeneo al suo interno. Lo suggerisce la stessa lunghezza dei rettangoli che negli esempi illustrati dalla figura 2 rimane sempre uguale nel corso degli anni (4 punti). Non è poco, anche le opinioni non sono polarizzate. Su altri temi e in altri momenti potrebbero esserlo.
Si potrebbe continuare lo stesso esercizio esaminando la configurazione spaziale di opinioni anche su altri temi di politica economica. Credo che alla fine troveremmo questo: l’esistenza di un numero elevato di centri e di segmenti centrali potenzialmente maggioritari, più o meno omogenei al proprio interno, quanto lo è il numero di temi sui quali le opinioni pubbliche dicono la loro.
In definitiva una politica che guarda al «centro» inteso in questa prospettiva è profondamente diversa da quella che emerge nei ragionamenti abituali sul «centro». Quest’ultima è una politica che immagina ci siano isole ideologiche ben distinte sparse in un arcipelago, isole da collegare costruendo ponti la cui manutenzione è affidata a mediatori.
Al contrario, la politica di massa è costretta a conquistare la maggioranza degli elettori tenendo conto della configurazione multi-dimensionale delle loro preferenze. Non esiste un solo centro, ma più d’uno. Tutto ciò rappresenta una sfida enorme alla rappresentanza democratica. Se ne esce solo con più leadership, individuale o collettiva poco importa. Ma è questa che spesso manca, perché non ci si vuole prendere il rischio di tener conto delle opinioni delle diverse maggioranze finendo per farsene travolgere.
Prendiamo il caso delle opinioni degli italiani sulla guerra.
Secondo un’indagine svolta nell’ultima parte del 2024, alla domanda con che parte stava nel conflitto russo-ucraina, l’8% rispondeva «con la Russia», il 35% «con l’Ucraina» e il 57% «con nessuna delle due parti». Nel dicembre 2022 chi non stava né con la Russia né con l’Ucraina era il 47% (come scritto da Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera del 31.12.2024). Nel febbraio 2022, al momento dell’invasione russa, i neutrali erano invece il 37% e il 58% diceva di stare con l’Ucraina (comunicazione personale).
In breve, gli italiani dopo quasi 3 anni di guerra hanno cambiato radicalmente opinione e sono approdati a una posizione d’indifferenza tra aggredito e aggressore. Ciò è accaduto nonostante il fatto che i governi italiani che si sono succeduti dal febbraio 2022 abbiano mantenuto sempre un fermo sostegno all’aggredito e altrettanto abbia fatto buona parte delle forze politiche.
Ci sarebbe molto da riflettere sulle ragioni della divaricazione tra l’opinione pubblica e le decisioni del Governo, una frattura presente non solo in Italia. Tuttavia, rispetto al tema di questa nota, mi sembra plausibile pensare che tener fermo il sostegno all’Ucraina non sia bastato. Ci sarebbe stato bisogno di una leadership capace di spiegarne bene le ragioni, come quella di Roosevelt nel 1941, quando fronteggiava un’opinione pubblica americana decisamente contraria all’intervento in guerra a fianco dell’Inghilterra.
Paolo Segatti