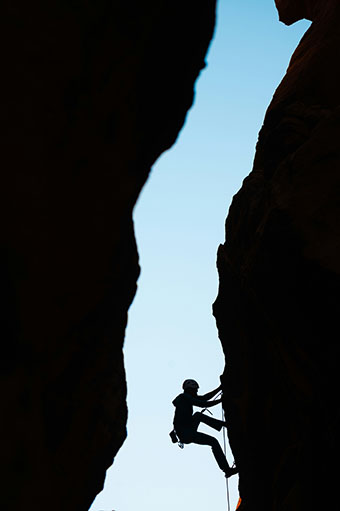Crisi finanziaria - L’Italia 10 anni dopo: il problema è la crescita
L’Italia si trova oggi «all’uscita faticosa e incerta dalla peggiore recessione della sua storia moderna». Innescata nel 2008 da «una crisi finanziaria di gravità senza precedenti», il bilancio che, a distanza di dieci anni, possiamo trarne è «quasi di guerra»: sia in relazione alla media dei paesi dell’area euro che ai maggiori due, Francia e Germania, «le perdite sopportate dall’economia italiana risultano le più consistenti e persistenti», così che nel nostro paese il «trend di crescita risulta compromesso». La definizione di una strategia di rilancio della crescita può giovarsi di un’analisi ormai condivisa: vi è un divario di produttività all’interno delle nostre imprese e tra l’Italia e gli altri paesi europei, il quale tende a ricomporsi con troppa lentezza e in maniera disomogenea, così che «il sistema produttivo italiano appare sempre più polarizzato». «Problemi strutturali» che richiedono «interventi imprescindibili»: sul «capitale umano», migliorando soprattutto la «qualità del sistema d’istruzione», e sul «capitale fisico, investendo in infrastrutture».
La lettura dell'articolo è riservata agli abbonati a Il Regno - attualità e documenti o a Il Regno digitale.
Gli abbonati possono autenticarsi con il proprio codice abbonato. Accedi.